Negli ultimi trent’anni la questione dell’acqua ha conosciuto un crescente interesse, riscontrabile dal gran numero di studi effettuati da parte di accademici e, soprattutto, di Stati ed organizzazioni internazionali. Strettamente legata alla questione demografica mondiale, ma anche a quella del cambiamento climatico, l’acqua è stata paragonata al petrolio, guadagnandosi l’appellativo di “oro blu”, risorsa quindi di ricchezza, se non di sopravvivenza stessa, per alcune zone del pianeta . Per citare Norman Myers, membro del Green College di Oxford e consulente per la Banca Mondiale: “Con l’acqua si sopravvive, senza non esiste cibo o sostentamento di sorta”; proprio la Banca Mondiale già nel 1995 avvertiva che la terra può conoscere una grave crisi idrica: ogni vent’anni la domanda raddoppia e già ottanta Stati che compongono il 40% della popolazione totale, conoscono una forte scarsità di questa risorsa . L’area mediterranea e quella mediorientale sono fortemente toccate dalla questione; basti pensare che nel giro di una generazione in Medio Oriente ogni abitante dispone dell’80% di quantità d’acqua in meno, mentre otto Stati mediterranei si trovano al di sotto della soglia critica di 1000 m ³ per abitante all’anno e che Israele, Giordania, Libia, Malta, Territori palestinesi e Tunisia sono addirittura al di sotto del valore di massima scarsità (500 m ³ abitante/anno) . La regione mediorientale soffre quindi per la scarsità d’acqua, aggiungendo questo fattore fra i molteplici motivi di instabilità e di frizione fra i vari Stati che la compongono. Generalmente, come vedremo nel paragrafo dedicato, gli studiosi tendono a dividersi nettamente in due gruppi distinti sulla questione conflittualità/acqua: coloro che, pessimisti od ottimisti, sottolineano quanto l’acqua sia una questione sottostimata e che ha, o avrà, profonde implicazioni geopolitiche; quelli che negano tale centralità facendola rientrare in discussioni di più ampio respiro di politica economica, o comunque in cornici più vaste. 3.1.2 Area meridionale e mediorientale Procediamo, quindi, ad una panoramica nelle due aree di interesse, soffermandoci prima sul bacino mediterraneo, per poi concentrarci sulla Turchia. Per il bacino Mediterraneo, bisogna innanzitutto ricordarne l’accentuata irregolarità del regime acquifero che scaturisce da due fattori principali, quali il clima, che conosce siccità estiva sommate a precipitazioni forti e concentrate, e l’orografia, caratterizzata da numerose zone montagnose. Le precipitazioni medie annue variano drasticamente a seconda della posizione: se nel nord, soprattutto grazie alla presenza di montagne, si registrano 10 milioni di m ³ per km quadrato (10 m all’anno), nella parte meridionale questa cifra scende vertiginosamente a 10 mila m ³ per km quadrato (1 cm all’anno) . Quindi dei 985 km ³ annui d’acqua il nord Mediterraneo ne detiene il 74%, la parte orientale il 21, mentre solo il 5% è concentrato a meridione; i due terzi delle risorse sono nelle mani di pochissimi Stati ossia Italia, Francia, Turchia e repubbliche ex jugoslave. A ciò si aggiunga che, fra i vari paesi rivieraschi, la Spagna, la Francia, l’Italia, l’Albania, la Turchia, Cipro, il Libano, la Giordania, la Libia, la Tunisia, l’Algeria ed il Marocco dispongono di risorse totalmente interne mentre Egitto, Siria ed Israele dipendono per l’approvvigionamento da altri Stati (rispettivamente per il 98%, l’80% ed il 55%). Dividendo gli Stati per m ³ annui per abitante, troviamo: al di sotto dei 500 m ³ Tunisia, Malta, Libia, Israele più Territori e Giordania; inferiori a 1000 m ³ Algeria ed Egitto; inferiori a 3000 m ³ Libano, Marocco, Spagna, Cipro e Siria; superiori a 3000 m³ Francia, Italia, Ex Jugoslavia, Albania, Grecia e Turchia. Per quanto riguarda i fiumi, solo ventuno superano una superficie di 10000 km ² e solo tre di questi (Nilo, Reno e Po) i 50000 km ²; inoltre molti di questi bacini attraversano più di un paese, si pensi al Nilo condiviso da dieci Stati. Fonte: Canepa M., Tutto comincia dall’acqua, 2001, op. cit. p. 187. Guardando, invece, all’uso agricolo, specificatamente all’irrigazione, oltre al problema d’efficienza delle tecniche tradizionali che riduce ad un 40% la resa media, i paesi meridionali vedono scendere tale percentuale ad un 25-30% a causa dell’elevata evaporazione. Sulle ipotesi per i consumi tra il 2010 ed il 2025, il Plan Bleu pour la Mèditerranèe ha sviluppato una ricerca basata sui dati effettivi degli anni ‘90 dando due possibili trend: uno per alti consumi ed un altro per quelli bassi. Si proietta per la fine del periodo in esame una differenziazione per le tre sottoregioni, dove quella settentrionale potrebbe conoscere una diminuzione dei consumi al –23% (bassi) o un aumento al 24% (alti), mentre la regione orientale, un aumento dal 27 al 130% (con valori maggiori al doppio per Turchia, Cipro, Libano, Palestina e Giordania), la regione meridionale, un aumento dal 21 al 71% (con valori triplicati per Algeria e Libia) .
Ankara in Eurasia, tra economia ed energia

Finita l’era di contenimento della politica estera turca imposta dalla Guerra Fredda, e frustrata dalla mancata adesione all’Unione Europea, Ankara decide di concentrare i suoi sforzi nell’area lanciando il progetto “Via della seta per il XXI secolo” . La politica estera turca abbandonò la precedente dottrina basata sull’imperativo “security first”, per una più conciliante ed aperta al compromesso, riassumibile in “pace attraverso il commercio”.
In tale contesto nacque, nel 1994, un gruppo informale detto dei “Sei” a cui aderirono Turchia, Azerbaidjan Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbekistan e Turkmenistan. Si venne a creare, quindi, un asse est-ovest che ad alcuni sembrò ripercorrere gli interessi delle compagnie petrolifere anglosassoni, “quasi a segnare geograficamente la propagazione dell’influenza occidentale nel cuore dello spazio post-comunista” . L’obiettivo turco sembrò essere quello di “lasciare i panni” di elemento marginale nell’economia occidentale, per prendere quelli di snodo geo-economico, tratto di unione fra est ed ovest. Sempre in tale cornice, sembrò poi poter essere inserita l’operazione di rianimazione dell’Organizzazione di cooperazione economica (Eco) compiuta da Turchia, Iran e Pakistan con l’introduzione dei paesi dell’Asia centrale, ivi compresi Afganistan e Azerbaidjan .
Nel presentarsi come Stato modello, la Turchia si propose come fornitore di crediti agevolati, investitore nei settori produttivi, adviser per le burocrazie statali e finanziarie, così da dare linfa ad un Commonwealth turcofono, basato su di una moneta unica comune il “dinar islamico”. Nel 1997 le linee di credito concesse all’Eurasia sfiorarono il miliardo di dollari, centinaia di joint-venture fiorirono soprattutto nei settori edilizio, commerciale e turistico dando spessore all’interventismo turco. Nonostante ciò, l’utopia panturchista di Turgut Ozal non prenderà mai corpo per molteplici motivi. In primis, quello che molti fanno notare è il “lirismo” di tale politica estera, sviluppatasi sotto pressione americana, priva di solidità finanziaria e convinta della totale marginalità di Mosca. In secondo luogo, oltre ai limiti oggettivi dell’economia turca, dettati dalla sua dimensione e dal suo debito estero pari a 80 miliardi di dollari nel 1997, bisogna aggiungere che tra il 1994 ed il 1995 questa venne scossa da una crisi economica e da un’inflazione a tre cifre, con conseguente perdita di appeal di Ankara ed una diminuzione costante dei suoi flussi di capitale verso l’area (nella seconda metà dei ’90 chiudono 200 joint-venture nel solo Azerbaidjan) . Inoltre, tra il 1993 ed il 1994, tutti gli Stati turcofoni (escluso il Kirghizistan) scoprirono il facile e lucrativo business petrolifero, quando Chevron e Kazakhoijl e Bp/Amocco e Socar (azera) firmano super-contratti per l’esportazione di “oro nero”; da quel momento, gli Stati Uniti diventarono primi attori nella regione, con l’intento di soffocare qualsiasi tentativo russo di riacquistare potere nell’area e di limitarne l’accesso alle riserve petrolifere e di gas. Ankara, che si presentava quale emissaria di Washington, perse allora anche questo strumento di pressione politica. Ulteriore motivo del declino dell’influenza turca risiedette nel suo essere percepita come troppo ingombrante, fratello maggiore che ricompare dopo decenni e che si vuole subito sostituire a Mosca come attore egemone. In un contesto come quello, i nuovi Stati appena indipendenti difendevano gelosamente la loro sovranità, sia per godere della propria indipendenza, sia anche perché le classi dirigenti locali, con una concezione patrimoniale dello Stato dove la corruzione era molto diffusa, temevano una limitazione ai loro affari d parte turca . Infine, l’area soffriva di una certa instabilità con Azerbaidjan e Armenia in guerra sino al 1994, conflitto nel quale alcuni sostengono potesse partecipare la Turchia in difesa di Baku a discapito di Mosca ma, dove “l’intervento di Ankara fu evitato in extremis dal maresciallo Chapochikov, comandante in capo delle forze armate Cei, che evocò una possibile dissuasione nucleare avvertendo che sarebbe potuta scoppiare una Terza Guerra mondiale. Questa è stata sicuramente la prova più dura che le relazioni turco-russe abbiano mai fronteggiato” . Altri invece sostengono che l’appoggio di Ankara fosse solo propagandistico . Rimase il fatto che bisognò aspettare sino al 19 settembre 2010 per assistere alla riconciliazione fra Armenia e Turchia, quando vennero firmati due protocolli: il primo per lo scambio di diplomatici fra i due paesi, il secondo per l’apertura dei reciproci confini .
Sul versante energetico, invece, la Turchia ottenne migliori risultati, entrando nei favori sia di Mosca che di Washington.
Da parte russa venne premiata la fine dell’appoggio di Ankara al separatismo ceceno (sancita ufficialmente dalle dichiarazioni del presidente Demirel che condannò il terrorismo legandolo alla questione cecena, presentata come fattore di instabilità per l’intera regione ) con la promessa di fornire gas per 20 miliardi di dollari in vent’anni, grazie alla realizzazione di un gasdotto sottomarino nel Mar Nero, il Blue Stream . Tale progetto, che coinvolse attivamente anche l’Eni come società costruttrice, iniziò ad essere realizzato dal 1997 e avrebbe potuto essere in funzione già nel 2003, ma le trattative fra Turchia e Russia sul prezzo della materia prima ne ritardano l’inaugurazione al 2005 . Tali accordi, inseriti nella cornice di quelli take or pay (clausola inclusa nei contratti di acquisto di gas naturale, in base alla quale l’acquirente è tenuto a corrispondere comunque, interamente o parzialmente, il prezzo di una quantità minima di gas prevista dal contratto, anche nell’eventualità che non ritiri tale gas) fanno della Russia il maggior fornitore di gas della Turchia, con un approvvigionamento annuo per 30 km ³. Oltre al gas Mosca è disponibile a fornire petrolio; questo dovrebbe fluire, sempre passando per il Mar Nero, attraverso l’oleodotto Samsun-Ceyhan (SCP, anche: Trans Anatolian Pipeline) – pensato per baypassare il Bosforo dove Ankara vuole limitare il traffico- che dovrebbe pompare dal 2012 da un milione ad un milione e quattrocentomila barili al giorno, progetto nel quale ritroviamo l’Eni. La Russia, che già negli anni ’90 vedeva figurare la Turchia fra i suoi primi cinque partner commerciali, ha visto crescere sempre più l’interscambio con Ankara, che nel 2008 toccava la cifra record di 36 miliardi di dollari, spesi soprattutto per l’acquisto di idrocarburi ed oggi, sembra voler espandere i propri servizi energetici alla costruzione di centrali nucleari in suolo turco .
Da parte americana, invece, si delineò, dal 1995, l’ipotesi di un oleodotto passante per Azerbaidjan, Georgia e Turchia, così da rendere marginale quello russo Baku-Novorossijsk. L’oleodotto Baku–Tiblisi–Ceyhan (BTC), inizialmente concepito per passare sul suolo armeno (opzione politicamente impossibile vista la guerra fra Azerbaidjan ed Armenia) invece che georgiano (ed essere quindi più economico) ha conosciuto nel 1998 l’opposizione di parti dell’establishment americano, visti gli incrementi di costi che le compagnie Usa avevano conosciuto nell’oleodotto Baku-Supsa (+ 200 mln di dollari) ed il ribasso dei prezzi del petrolio caspico, crollato in quel periodo da 20 a 10 dollari al barile . A queste titubanze, che avevano prodotto nuovi progetti di oleodotto da Supsa a Burgas dove Ankara sarebbe scomparsa, la Turchia risponse emendando unilateralmente la convenzione di Montreux, e quindi modificando il traffico di petroliere per i suoi stretti adducendo motivazioni di carattere ambientale. La costruzione del BTC partì infine nel 2002 per concludersi nel 2005, raggiungendo la capacità di trasporto di circa un milione di barili al giorno. Alcuni fanno notare che gli Usa abbiano optato per il progetto BTC in segno di riconoscenza ad Ankara, che nella guerra del Golfo del 1990-1991 si era dimostrata un valido alleato e che a conseguenza dell’embargo imposto all’Iraq, aveva dovuto chiudere l’oleodotto Kirkuk-Yumurtalik ed aveva conosciuto un forte calo di transito nel porto di Ceyhan . Da questi primi accordi, Ankara pose le basi per trasformarsi in un hub energetico, ponte di collegamento fra oriente ed occidente anche sul piano fondamentale dell’energia.
Archiviato in Turchia
La Turcofonia, la lingua come strumento di potere
La lingua turca, diffusasi nelle sue diverse declinazioni fra circa 125 milioni di persone divise in almeno 15 Stati , appartiene alla famiglia altaica: lingua da sempre disomogenea (la razza turca, nomade e guerriera, era infatti divisa in una ventina di tribù, ognuna con il proprio dialetto) ha conosciuto una prima sostanziale differenziazione nel VIII secolo D.C., quando queste tribù si divisero in due percorsi migratori contraddistinti: verso Ovest, marciando a settentrione o meridione del mar Caspio, o verso Est, in direzione Cina. Ciò nonostante, dal punto di vista della sintassi, della morfologia e della fonetica, rimangono una certa omogeneità ed importanti similitudini fra le sue sottofamiglie (v. tabella 1).
Tabella 1 “Classificazione dei rami e delle sottodivisioni della lingua turca” *
Oghur Kiptchak
(Nord-Ovest) Oghuz
(Sud-Ovest) Ouïghour
(Sud-Est) Siberiano
(Nord-Est) Arghu
Oghur **
Tchouvache OVEST
Tartaro di Crimea
Karatchaï-
Balkar
Koumyk
Karaim
NORD
Tartaro
Bachkir
Kouman**
SUD
Cosacco
Kirghiz
Karakalpak OVEST
Turco della Turchia
Turco d’Azerbaïdjan
Gagaouze
EST
Turkmeno
Turco del Khorasan **
SUD
Kachkaï
Afshâr
Salar
Tsagataï
Tsagataï **
OVEST
Ouzbèko
EST
Turco antico **
Ouïghour
Yugur
Ainu
Turco Ili NORD
Iakoute
Dolgan
SUD
Jenisseï-Chakas
Touvin di Saya
Altaï
Tchoulim Khalaj
(*lista non completa)
(**lingue morte)
Fonte: Raptopoulos N., La famillie de langues turques et le dèfi de crèation d’une communautè turcophone en Eurasie: le role assumè par Ankara, in «Revue internationale de politique comparèe», n. 14, 2007/1, p. 148.
A grandi linee si possono distinguere tre direzioni cardinali di espansione della lingua: Oriente, Occidente e Settentrione (cfr., tabella 2). Per turchi d’occidente si intendono quelli abitanti dall’Adriatico al Caspio (più o meno il vecchio Impero Ottomano), dove risiedono 65 milioni di turchi e 50 milioni di turcofoni, così facendone l’area più importante fra le tre. Per turchi orientali ci riferiamo alle Repubbliche centrasiatiche ed ai territori a loro periferici di Cina, Iran ed Afghanistan; infine per turchi del nord – i meno numerosi fra tutti – intendiamo quelli residenti nelle aree settentrionali alle due precedenti, quindi dall’alto Volga alla Siberia, dove, vista la perifericità di tali regioni, la lingua locale è rimasta isolata dal restante mondo turcofono assurgendo a status di lingua autonoma.
Tabella 2 “Le tre aree turcofone in Eurasia”*
Turchi d’occidente Turchi d’oriente Turchi settentrionali
Azerbaijan
Bulgaria
Iran
Iraq
Romania
Siria
Tracia Occidentale
Turchia
Kosovo
Cipro
FYROM
Moldavia Kazakhstan
Ouzbekistan
Kirghikistan
Turkmenistan
Karakalpakstan
Yugur Sakha (Siberia)
Urali orientali
Altai
Bachkirs
Tartari
Crimea
Touva
Khakassia
Balkars
Karatchaïs
Karapapaks
Nogaïs
Koumyks
(* lista non completa e generale)
Fonte: Raptopoulos N., La famillie de langues turques et le dèfi de crèation d’une communautè turcophone en Eurasie: le role assumè par Ankara, op. cit., p. 149.
Tabella 3 “Le entità turcofone in Eurasia”
Repubbliche indipendenti Repubbliche federate Regioni autonome
Azerbaidjan
Kazakhstan
Kirghizistan
Ouzbekistan
Turkmenistan
Turchia
Cipro Nord Azerbaïdjan
La Repubblica di Nakhitchevan
Ouzbékistan
La Repubblica di Karakalpakstan
Federazione russa
La Repubblica d’Altaï
La Repubblica di Bachkirie
La Repubblica di Kabardino-balkarie
La Repubblica di Karatchaïévo-Tcherkessie
La Repubblica di Khakassia
La Repubblica di Sakha
La Repubblica di Tatarstan
La Repubblica di Ciuvascia
La Repubblica di Touva
Ukraine
La Repubblica autonoma di Crimea Cina
Xinjiang
(Turkestan Orientale)
Moldavia
Gagauzia
Fonte: Raptopoulos N., La famillie de langues turques et le dèfi de crèation d’une communautè turcophone en Eurasie: le role assumè par Ankara, op. cit., p. 149.
Questa dispersione dell’etnia turca ha prodotto evoluzioni diverse per ogni ramo della lingua, legate ai differenti contatti avuti con le popolazioni indigene che spesso si trovarono ad essere assoggettate politicamente e culturalmente dai turchi, come dimostra il permanere in tali aree dell’alfabeto o della lingua stessa. L’influenza non è però da intendersi in senso univoco. Basti pensare all’impero Ottomano (fondato dai Selgiuchidi discendenti dalla tribù turca di Oguz) dove la lingua ufficiale dell’impero non fu solo il turco ma anche l’arabo ed il farsi . Per i turchi residenti nell’impero russo, invece, nel XIX secolo le autorità zariste imposero che queste abbandonassero il loro alfabeto arabo per abbracciare quello cirillico, così da separarle dai loro fratelli linguistici .
Quest’ultima politica verrà ripresa anche dall’URSS pur se con qualche differenza. Nel 1926 si tenne a Baku il Congresso dei turcologi che proponeva la creazione di una “Federazione della lingua turca” e la sua modernizzazione attraverso l’abbandono definitivo dell’alfabeto arabo a vantaggio di quello latino; le autorità sovietiche accettarono l’utilizzo dell’alfabeto latino ma con l’aggiunta di alcune lettere cirilliche; questo nuovo alfabeto avrà però vita breve (1928-1938). Infine Stalin, sul tramontare degli anni ’30, per evitare che le popolazioni turche abbracciassero sia l’islamismo sia il nazionalismo impose nuovamente l’alfabeto cirillico .
Anche nella neonata Repubblica di Turchia l’ideologia kemalista comprese quanto la lingua turca sia stata per sintassi, morfologia e scrittura legata ai valori del defunto impero. Iniziò, quindi, un’opera di “purificazione” della lingua attraverso l’eliminazione di parole arabe o farsi, ma soprattutto grazie al passaggio dall’alfabeto arabo a quello latino nel 1928 poi seguite, nel 1932, dalla creazione della Società di studio della lingua turca . Quest’ultima avrà un’importante ruolo nel costruire la nuova identità post-imperiale per i cittadini turchi, la quale – come abbiamo visto in precedenza – pone un forte accento sulle origini mitiche di un unico popolo turco, elemento poi ripreso dall’estrema destra panturchista .
Si è detto che la lingua turca ha subito profonde modificazioni sia da culture esterne ma soprattutto da azioni politiche dirette. Quando con la caduta del muro di Berlino Ankara si lanciò in Eurasia, portò avanti anche lei un progetto politico per riformare la lingua turca. I paesi turcofoni sotto la guida turca decisero di approfondire i loro rapporti politici ed economici utilizzando lingua e cultura turche come vettori; è un evento di portata storica poiché, almeno dal 1920, i rapporti fra repubblica kemalista e popolazioni turche sovietiche sono ridotti alle iniziative dei singoli.
Lo strumento scelto per questo riavvicinamento culturale è il modello linguistico francese, ossia la riunione annuale di Capi di Stato in Sommet dei paesi turcofoni, dove discutere di lingua ma soprattutto di politica. Il primo, datato 30-31 ottobre 1992, si svolse ad Ankara dove si provò a delineare quale tipo di cooperazione potesse esistere – un’unione oppure una vaga confederazione – ma si delineò anche la volontà di utilizzare tutti lo stesso alfabeto . La formula dei Sommet entrò però in crisi già nel 1993, quando alcune repubbliche sottolinearono le promesse mancate da parte di Ankara e, soprattutto, il fatto che questa partecipasse attivamente ai loro affari interni (ad esempio l’appoggio a certi movimenti politici ouzbeki o azerbaigiani). Saltò, quindi, l’incontro previsto in Azerbaidjan e, se guardiamo l’intero periodo 1992-2006, si nota che si sono svolti solo otto incontri, di cui quattro in Turchia (cfr. tabella 4).
Tabella 4 “Sommet dei Capi di Stato dei paesi turcofoni (1992-2006)”
1. Ankara, Turchia, 30-31 ottobre 1992
2. Istanbul, Turchia, 17-18 ottobre 1994
3. Bichkek, Kirghizistan, 28 agosto 1995
4. Tachkent, Ouzbékistan, 21 ottobre 1996
5. Astana, Kazakhstan, 9 giugno 1998
6. Baku, Azerbaïdjan, 8-9 aprile 2000
7. Istanbul, Turchia, 26-27 aprile 2001
8. Antalya, Turchia, 17-18 novembre 2006
Fonte: Raptopoulos N., La famillie de langues turques et le dèfi de crèation d’une communautè turcophone en Eurasie: le role assumè par Ankara, op. cit., p. 150.
Comunque, dal 1992, Azerbaidjan, Ouzbekistan e Turkmenistan hanno accettato l’obiettivo principe di Ankara, ossia l’unificazione graduale delle loro lingue ed alfabeti sul modello di quello utilizzato in Turchia. Nel 1992 venne appunto creata l’Agenzia di cooperazione e sviluppo turco, con lo scopo di fornire aiuto e consigli ai paesi turcofoni per approfondire la cooperazione culturale a livello linguistico . Sarà proprio questa agenzia a colmare il vuoto del Sommet del 1993, convocando una conferenza per quell’anno ad Ankara, dove si decise per l’adozione di un alfabeto composto da una trentina di lettere (proposta però ignorata da molti Stati della regione) .
La politica linguistica di Ankara venne supportata grazie a numerose iniziative di stampo culturale, coordinate dalla Direzione generale dell’amministrazione comune delle arti e delle culture turche (TURKSOY). Quest’agenzia nasce nel 1993, come frutto delle riunioni dei Ministri degli affari culturali dei paesi turcofoni svoltesi nei Sommet di Ankara e Baku, per promuovere la cooperazione culturale. Alcuni autori hanno sottolineato le grandi ambizioni del Turksoy, definendola l’Unesco della turcofonia .
Anche il campo educativo non venne tralasciato, con la Turchia atta a promuovere cicli di studio secondario e terziario in lingua turca nelle repubbliche e programmi di insegnamento per turcofoni in patria; vennero fondate due università, quella di Ahmet Yesevi in Kazakhstan e quella di Manas in Kirghizistan, e concesse un gran numero di borse di studio universitario (33363 nel periodo 1992-2004 ) per studenti provenienti dall’Asia e dai Balcani. Nell’analizzare i flussi di studenti iscritti ogni anno nelle università turche, soggetti a forti fluttuazioni dovute anche ad abbandoni per la poca consistenza delle borse di studio, si fa notare come questi siano un: “formidabile termometro delle relazioni fra la Turchia e questi Stati. Quello che invia più studenti resta il Kazakhstan. L’Ouzbekistan, che è il paese più popoloso dell’Asia centrale, ne invia al contrario sempre meno, a causa del deteriorarsi delle sue relazioni con Ankara: 438 persone tra il 1996-1997, 12 al gennaio 2000 in prossimità della crisi fra i due paesi. Gli studenti turkmeni sono sempre più numerosi: nel gennaio 2000 raggiungono il numero di 1800” . Lo stesso autore fa anche notare che i giovani turchi, che sono andati a studiare all’estero, hanno seguito un andamento opposto concentrandosi proprio in quegli Stati che inviano meno studenti in Turchia come l’Ouzbekistan. Oltre agli scambi di studenti, Ankara ha aperto tredici licei sia scientifici che tecnici, due in Kirghizstan, otto in Ouzbekistan e tre in Turkmenistan, gestiti dagli attachè linguistici delle ambasciate. Inoltre, il Ministero dell’educazione turco lanciò un programma per la redazione di testi scolastici di storia e letteratura comuni a tutte le Repubbliche turche (tuttavia senza ottenere che fossero adottati); questi sono redatti sullo stampo di quelli nazionali, correlati dalla foto di Ataturk, dalla bandiera turca, da una cartina amministrativa della Turchia e da un’altra inserita dopo il 1991, del mondo turco .
Con l’intento di coinvolgere le masse nella propria politica culturale, Ankara decise di utilizzare lo strumento audiovisivo lanciando due canali televisivi Avrasya e trt International, entrambi legati alla piattaforma Turksat; le risposte dei vari Stati a tale iniziativa furono differenti, in base alla loro volontà di apertura ed al loro interesse verso la cultura turca, con Turkmenistan e Kazakhstan che richiesero molte più ore di trasmissione di Ouzbekistan e Kighizstan . I programmi trasmessi, si concentrarono sulla diffusione di informazioni dal mondo turco, abbracciando letteratura, geografia e storia di ciascun paese senza mai dare l’impressione di concentrarsi troppo sulla Turchia che però è sempre presente fra le righe, sia per i contenuti dei programmi sia per la lingua utilizzata . Sulla lingua, il progetto iniziale prevedeva l’utilizzo di una forma semplificata del turco così da essere più facilmente compresa nell’area, ma ciò non è mai avvenuto; forse questo può spiegare lo scarso interesse a livello popolare verso tali trasmissioni a scapito dei format russi o dei paesi confinanti . Rimane il fatto che Turksat è comunque conosciuta a livello globale e stimola gli ambienti intellettuali turcofoni, rimanendo un punto saldo per la diffusione della turchità nel mondo .
Tutti questi sforzi per diffondere la cultura turca (in senso lato) appena descritti, non sono da considerarsi fini a se stessi ma, bensì, all’interno di un disegno più ampio: ossia la creazione di un “mondo turco integrato” dove Ankara, grazie alla sua influenza, può giocare un ruolo di leader economico regionale. Se, come vedremo, gli sforzi della Turchia per creare un’unione economica sono falliti di fronte alla rapida rimonta russa ed alla concorrenza di Cina ed Iran, sul fronte energetico che rimane l’altro obiettivo principe di Ankara, i risultati sono stati molto più soddisfacenti.
Archiviato in Turchia
Ankara in Eurasia, l’Islam come ponte fra popoli
Come abbiamo già accennato, sei delle otto repubbliche centro-asiatiche condividono la fede musulmana: Azerbajdzan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Kirghizistan e Tadgikistan. Sebbene – come molti hanno osservato – la dominazione sovietica ha sicuramente laicizzato le loro popolazioni, una volta caduto il muro di Berlino il fattore “R” ha conosciuto una rivitalizzazione anche grazie agli sforzi di Arabia Saudita, Iran e Turchia, impegnate a diffondere il proprio modello di Islam.
In questo contesto l’opzione turca appare come quella di maggior successo poiché, da un lato, il Wahabismo saudita sembra mal conciliarsi con culture secolarizzate ed affamate più di consumismo che di rigide ideologie e, dall’altro lato, l’Iran soffre dello scarso appeal dello sciismo in un contesto a maggioranza sunnita .
Con il beneplacito e l’esortazione di Washington, interessata a sottrarre l’area da influenze “fondamentaliste”, Ankara sfruttò il legame religioso per penetrare nella regione, attraverso la propria Direzione generale per gli affari religiosi, il Diyanet. Agenzia governativa quest’ultima che sviluppa il concetto di “spazio islamico eurasiatico”, dove la Turchia viene immaginata come fulcro di un sistema d’integrazione cultural-religioso che si regge su di una galassia di strutture a matrice religiosa.
Il ruolo di pionieri spettò alle varie confraternite sufi che, anche per sottrarsi alle pressioni in patria, trovarono terreno fertile per le proprie fondazioni, imprese, ma soprattutto scuole private, e diedero il via ad una discreta ma incisiva opera di islamizzazione . Fra queste la confraternita più attiva sembra essere stata quella dei “partigiani della luce” fondata da B. Nursi, oggi guidata dal maestro/imprenditore Fethullah Gulen: da sempre improntata ad un’islamizzazione tramite l’educazione, questa confraternita è riuscita a creare un gran numero di attività in questa regione, sia economiche che culturali, tra le quali meritano di essere citate: il quotidiano Zaman, pubblicato nelle diverse lingue locali e le holding finanziarie Asya Finas e Isik Sigorta, note alle cronache per operazioni di riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico . La questione della droga, così distante dagli ideali filantropici del movimento religioso, trova una sua collocazione se arricchiamo il contesto di un fattore ulteriore: l’estremismo di destra turco, contiguo al mondo mafioso ed eversivo.
L’ambiente parafascista turco, infatti, è l’unico ad aver sempre sostenuto in patria un’ideologia panturchista, di sintesi turco-islamica dove il turco è rappresentato come campione-tipo dell’Islam ; in una congiuntura internazionale favorevole, il panturchismo ha rappresentato il trait d’union per quei gruppi religiosi/politici/criminali osteggiati in patria ma mai sopiti. Ankara risponse a questa deriva che, oltre a danneggiarla sul piano diplomatico, generò forti tensioni socio-politiche interne, attraverso la creazione di un Consiglio dell’Islam eurasiatico (Ais), antenna del Diyanet, costituito con altri 28 paesi riunitisi ad Ankara nel 1995, con lo scopo di costituire un’Organizzazione della conferenza islamica eurasiatica . L’Ais divenne, quindi, lo strumento accentratore delle politiche religiose turche che le organizzazioni extra-governative avevano intrapreso anche con il favore delle istituzioni; a queste l’establishment turco (soprattutto lo Stato Maggiore ed i partiti di sinistra) rispose anche con una campagna per “risvegliare le coscienze collettive” .
Nel 1996, sessantesimo anniversario della scomparsa di Ataturk, partendo dalla denuncia di infiltrazioni islamiste all’interno del ministero dell’educazione, si pose l’accento sul grave pericolo rappresentato dal connubio fra razzismo nazionalista turco e fondamentalismo religioso, che ebbe come bersaglio principalmente Fethullah Gulen; per alcuni, un ulteriore obiettivo sarebbe sembrato anche l’Arabia Saudita, impegnata con gli Usa a fomentare gruppi islamisti/mafiosi, secondo fonti dei servizi segreti turchi . La politica religiosa ufficiale soffrì, però, di poco dinamismo, limitando il suo campo d’azione alla traduzione in turco/lingua nazionale dei testi classici dell’Islam, alla costruzione/riparazione di moschee e sopratutto alla formazione del personale religioso regionale, attraverso l’istituzione di facoltà di teologia in loco od accogliendo studenti in patria. Vennero istituite facoltà presso Ashkabad (Turkmenistan), dove ha sede anche un liceo religioso, Och (Kirghizstan) e Chimkent (Kazakhstan), dove lavorano teologi qualificati turchi; queste strutture hanno attirato l’interesse delle popolazioni locali, sia perché praticamente gratuite, sia perché offrono corsi non incentrati soltantosulla religione ma anche di carattere internazionalista .
La religione non è che uno – e forse il più marginale – degli strumenti utilizzati dalla Turchia per “costruire ponti” nel suo “Oriente vicino”; gli sforzi maggiori sono stati spesi in ambito culturale, con particolare riferimento alla lingua.
La regione euroasiatica, conosciuta come Turkestan o Turan prima della colonizzazione sovietica, aveva destato l’interesse di alcuni circoli intellettuali ottomani nel XIX secolo, quando la scienza europea individua una comunità linguistica autonoma del ceppo uralo-altaico in concomitanza con l’affermarsi dalle ideologie panslave e pangermaniche. Anche presso la Sublime Porta, imitando lo zeitgeist europeo, si sviluppa una visione geopolitica basata sull’etnicità detta panturchismo , utilizzata soprattutto in chiave antizarista; questa dottrina uscirà politicamente sconfitta dalla Grande Guerra, visto che Ataturk, nella sua visione post-ottomana, cercò di intrattenere relazioni distese con l’URSS ritirando ogni pretesa turca dall’Asia centrale . Alcuni hanno fatto notare, però, che il panturchismo non venne a scomparire del tutto: bandito in politica è sempre stato coltivato all’interno del sistema educativo turco . Con la costruzione dello Stato, si elaborò all’interno della storiografia kemalista, e quindi dei manuali scolastici, un mito civilizzatore della razza turca che, partendo dai monti Altaj, illumina il mondo. Non c’è, quindi, da stupirsi se, per un verso, quando nel 1991 Ankara riallacciò le relazioni diplomatiche con l’area, i suoi media si lanciarono in trionfalismi quali il “XXI secolo sarà dei turchi” o la rinascita di un “mondo turco” e se, per altro verso, il presidente Turgut Ozal, durante un discorso all’assemblea nazionale, si presentò come portavoce dei “200 milioni di connazionali […] con cui è necessario costruire una comunità di stati dall’Adriatico alla Grande Muraglia” . Il sogno di Ozal sembra potersi riassumere in un progetto federativo su modello europeo, con la Turchia al centro e il fattore turcofono a dare linfa vitale a tale comunità.
Archiviato in Turchia
La Turchia in Asia Centrale: il Grande Gioco del ‘900
Dall’Europa, intesa come progetto politico a cui la Turchia sogna da anni di aderire, passeremo ora all’Asia centrale, dove i ruoli si ribaltano: cuì sarà lei stessa a tentare di costruire un’ “architettura internazionale” gravitante attorno alla Turchia, progetto grandioso e conclusosi con un nulla di fatto.
In questo capitolo analizzeremo gli sviluppi, dai primi anni ‘90 ai giorni nostri, del tentativo da parte di Ankara di ampliare la propria sfera di influenza politica, economica e culturale nelle Repubbliche ex Socialiste, con particolare riferimento alla regione centro-asiatica.
La questione merita un capitolo a sé stante, in quanto tocca almeno due tematiche fondamentali delle relazioni internazionali turche odierne: la prima riguarda lo sviluppo di una nuova e, relativamente, indipendente politica estera turca, possibile dal 1989 grazie alla caduta dell’URSS; la seconda, invece, risiede nella volontà della Turchia di assurgere a livello di potenza regionale, soprattutto sfruttando il proprio territorio come nodo o centro di smistamento per i flussi energetici provenienti da Oriente.
Con la caduta del muro di Berlino del 1989, un terremoto scosse le fondamenta dell’Unione Sovietica, lasciando gran parte delle sue province in una situazione di caos ed incertezza. Agli albori dei ‘90 le ormai ex Repubbliche Socialiste si aprirono al mondo, attirando gli appetiti di molti attori internazionali volenterosi di estendere la propria influenza in una regione ricca di materie prime, nonché passaggio obbligato per le rotte commerciali tra Oriente ed Occidente; la Russia, però, lungi dal ripiegarsi su sé stessa, tenta sin da subito di ricostruire la propria influenza – se non supremazia – sull’area in questione, evocando in molti studiosi (il F. Muller, l’A. Rosato, il V. Vielmini ma anche il P. Sinatti e lo I. Cuthbertson a solo titolo d’esempio) il ricordo del c.d. “Grande gioco” che vide contrapporsi Russia ed Inghilterra nel XIX secolo .
Si analizzeranno, quindi, brevemente le mosse del Cremlino nei primi anni ‘90, così da fornire una cornice storico-politica in cui inserire un’analisi più approfondita sulle manovre di Ankara e sulle sue motivazioni.
Mosca nel post ‘89
L’analogia del “Grande gioco” è sicuramente utile per il suo carattere evocativo, bisogna però sottolineare le numerose differenze che contraddistinguono i due periodi storici in esame così da non cadere in generalizzazioni troppo azzardate . Innanzitutto, nel 1800 la competizione avveniva fra due grandi potenze, con confini non contigui, che miravano ad espandersi su di una zona considerata dalla comunità internazionale come terra di nessuno; oggi, invece, nella regione risiedono Stati sovrani che possono accettare un certo livello di ingerenza straniera ma, certamente, non una dominazione come in passato. In secondo luogo, si è persa l’importanza della volontà di aprire nuove rotte commerciali a scapito dell’influenza diplomatica: se prima il commercio era il fine ultimo nella penetrazione delle grandi potenze, ora questo viene utilizzato, sia nelle forme di aiuto che di investimento, come mezzo per ricompensare o punire i vari attori regionali. In terzo luogo, la competizione è passata da un bipolarismo regionale ad un modello molto più complesso con Usa, Cina, Iran, Turchia, Arabia Saudita, ma anche India e Sud Corea, interessate ad avere un peso negli affari dell’area.
Ciò che invece è rimasto intatto dello spirito del ”Grande gioco” è la volontà dei vari attori di prevalere gli uni sugli altri e, possibilmente, di escludersi a vicenda, riportando in auge temi ottocenteschi di politica internazionale quali il concetto di bilanciamento di potere e di realpolitik, ben lontani dai sogni di fine della storia proposti da Francis Fukuyama.
Anche se, per un brevissimo periodo, la Russia di Boris Yeltsin sembrò seguire i passi della Germania post-nazista ed inserirsi supinamente nel “nuovo ordine mondiale” promosso dagli Stati Uniti; ciò nonostante, il vero potere decisionale russo non risiedeva tanto nelle mani dei dirigenti politici impegnati a tessere relazioni con l’Occidente ma, bensì, nelle élite militari impegnate in una coerente politica di riappropriazione dell’area di influenza di Mosca.
I militari proiettarono al di fuori dello Stato le loro mire di influenzare la politica, scegliendo come strumento la difesa delle comunità russofone nei nuovi stati indipendenti (25 milioni di individui percepiti come stranieri indesiderati). Tale progetto che permetteva, inoltre, di garantire la sicurezza nazionale, creando una serie di zone cuscinetto ad influenza russa, veniva interpretato dai Generali positivamente anche sul piano politico interno, dove si sarebbero potuti presentare come difensori della patria. L’agenda dei militari sopì quasi immediatamente le tendenze democratiche d’ispirazione occidentale, a favore di un approccio nazionalista dove la realpolitik prese il sopravvento, anteponendo l’interesse nazionale sia al diritto internazionale sia alle relazioni con le neonate repubbliche.
L’area dove ciò fu più evidente è la regione transcausica. Questa, immediatamente dopo il crollo dell’ordine sovietico si trovò in una situazione di semi-anarchia dove il potere veniva gestito da una galassia di signori della guerra; le prime avvisaglie di una politica militare russa indipendente si ebbero in Moldavia dove, sebbene Mosca avesse ordinato alla Quattordicesima Armata di non interferire negli scontri fra popolazione russa ed autoctona – siamo ancora nella fase di dialogo fra Russia ed Occidente -, il comandante in capo gen. A. Lebed disattese tali indicazioni. Quando scoppiò il conflitto fra Armenia ed Azerbijan, l’esercito russo incominciò a rifornire entrambi gli schieramenti. Sicuramente la volontà di arricchirsi grazie al conflitto ha influenzato gli ufficiali russi, ma se a questo episodio sommiamo il fatto che anche nella regione georgiana dell’Abkhazia arrivarono ingenti quantità di armi russe, la spiegazione ufficiale di un esercito fuori controllo non è più così convincente. Questo sospetto divenne subito chiaro quando Stati, come la Georgia, chiesero ed ottennero immediatamente la permanenza sul loro suolo delle armate russe in qualità di “peacekeeper”.
L’operazione di divide et impera portata avanti dalla Russia non si concentrò solo sugli attori regionali ma venne applicata anche a scapito delle due potenze più attive nell’area: l’Iran e la Turchia. Fornendo armamenti a tutte le parti belligeranti, infatti, Mosca fece in modo che entrambi gli Stati considerassero troppo oneroso un loro sostegno diretto ai movimenti di guerriglia, che avrebbe significato entrare in diretta competizione (anche militare) con la Russia.
Esaminata la politica militare russa nell’area (sicuramente efficace, basti pensare alla guerra lampo in Georgia del 2008), rimangono da verificarne le politiche economiche e culturali, dove il Cremlino sembrò soffrire di più.
Per quanto riguarda l’economia, intesa come strumento di controllo politico dell’Asia centrale, l’obiettivo principe rimase, e lo è tutt’ora, reintegrare la regione in un “sistema rublo”; questa opzione, indispensabile vista la concorrenza di dollaro, euro ma anche del renminbi cinese, rischiò di essere costosissima per l’economia russa, come dimostrò il caso della Bielorussia. La stragrande maggioranza delle economie regionali si trova in situazioni molto compromesse, quindi la Banca Centrale russa dovrebbe iniettare enormi flussi di liquidità senza modificare la produttività, causando non pochi problemi in patria, dove la popolazione vedrebbe nel breve periodo una decrescita dei propri standard di vita con possibili, ma non garantiti, ritorni nel medio/lungo termine.
Un sistema economico integrato, inoltre, per poter essere efficace, effettivo e durevole, necessita di un ingrediente ulteriore: un sistema culturale condiviso, capace di fornire un senso alle asettiche operazioni di mercato. Questo sembra essere il maggior ostacolo per Mosca, in un contesto dove tutte le ex repubbliche socialiste si sono impegnate non poco per crearsi una forte impronta nazionalista attraverso nuove bandiere, nuove monete ecc. Sebbene queste nuove narrazioni spesso non siano riuscite ad instillare un profondo nazionalismo nelle popolazioni, un obiettivo è stato raggiunto: i nuovi cittadini hanno la convinzione ben radicata di non appartenere alla cultura russa, di non volerne far parte, e che se la Russia non avesse per secoli esercitato la propria influenza, le cose sarebbero andate meglio. Proprio in questo vacuum culturale provò ad inserirsi la Turchia, che condivide con le popolazioni locali la religione (l’Islam sunnita) una comune radice linguistica turcofona e che si presenta come paese a rapida crescita economica che ha saputo sposare una modernizzazione occidentale ai propri valori tradizionali.
Archiviato in Turchia
L’unione doganale europea: i malumori di Ankara

Come abbiamo visto, il 1º gennaio 1996 entrò in vigore l’unione doganale tra UE e Turchia (progetto risalente al 1964), presentata come primo passo verso l’integrazione di Ankara, come strumento per avvicinarla alle prassi economiche comunitarie e divenuta il limbo nel quale sembra essere confinata a tempo indeterminato.
All’interno di questa cornice la Turchia ha compiuto sforzi, non solo economici ma anche politici, per essere accettata come membro dell’Unione, quali l’abolizione della pena di morte e le modifiche apportate alla propria costituzione . Oltre a questa condizione, certamente scomoda per Ankara, bisogna aggiungere che l’unione doganale danneggia l’economia turca quando questa non è applicata, o lo è solo parzialmente, ai settori dei servizi, ai prodotti agricoli, al carbone, all’acciaio ed al tessile che sommati, compongono circa la metà della produzione economica turca .
L’Unione applica, quindi, misure di protezionismo unilaterale verso le esportazioni turche e, forse grazie anche a queste, è riuscita ad assicurarsi un surplus commerciale nella propria bilancia dei pagamenti, per di più crescente; si pensi che il deficit turco nelle relazioni bilaterali è passato da 7,1 miliardi di euro nel 2004 a 8,4 già nel 2006 . Sinora Ankara sembra sopportare tale esborso, come “dazio” per il suo percorso verso l’integrazione , ma visto il tentennante andamento dell’economia comunitaria degli ultimi anni, che ha risentito fortemente della pesante crisi economica ancora in corso, c’è da chiedersi per quanto tempo la Turchia sia ancora disposta ad accettare che sia Bruxelles a determinare la propria politica economica. In qualità di non membro dell’Unione infatti, Ankara non ha alcuna possibilità di discutere le politiche commerciali comunitarie, che però deve rispettare in qualità di membro dell’unione doganale; si guardi, ad esempio, al 2005 quando la Ue impose l’interruzione delle importazioni tessili dalla Cina – dalla quale la Turchia importa gran parte delle materie prime per le proprie industrie tessili – ed anche Ankara dovette sottomottersi a tale diktat, penalizzando le proprie aziende che fermarono la produzione per settimane .
Dal punto di vista politico, l’unione doganale rappresenta, di fatto, un’adesione parziale ed asimmetrica della Turchia all’Unione , rimanendo così quello di Ankara – non casualmente – l’unico caso di paese che apre le proprie dogane e delega una prerogativa sovrana alla Ue senza prima esserne parte.
Archiviato in Turchia
To be or not to be…
Oggi mi espongo, per una volta scriverò un post più ricco di riflessioni che di fatti. Idee bizzarre direi, tipo: Maroni ha ragione, un solo Stato non può affrontare il dramma dei profughi/immigrati/rifugiati, chiamateli come volete. Come la saggezza popolare ci insegna: nascondere la polvere sotto il tappeto non serve a nulla. L’Europa ha ignorato la questione per troppo tempo, sperando che, il Medio Oriente, un’area a natalità da boom demografico ( età media sotto i 20 anni), una situazione politica (dittature varie) ed economica (salari medi sotto i 300 $), guardasse che ne sò, allo Zimbawe, come polo di attrazione. Dimenticandosi inoltre l’etimologia del termine, chi è il Vicino Oriente, l’Europa forse?
Detto questo, sono anche disgustato da come il nostro paese abbia strumentalizzato politicamente la vicenda. Si sono create incertezze in una drammatica situazione, quella di ragazzi che fuggono da inferni (che spesso noi abbiamo appoggiato, armato e addirittura creato), ammassandoli come bestie con un litro d’acqua a testa, senza servizi igienici ed affrontando l’emmergenza giorno per giorno, senza un programma. Ora minacciamo anche di abbandonare la famiglia europea.
Certamente questo è il periodo più buio che il sogno comunitario abbia mai attraversato, fatta l’Ue non si sono fatti gli Europei ed in molti Stati rifiorisconosentimenti nazionalsti, se non separatisti (dall’Unione, dallo Stato, un pò da tutto, torneremo alle Città Stato?). In un mondo ormai globale bisogna però chiedersi se il gioco separatista valga la candela, metà Belgio, un terzo di Spagna o di Italia, la Corsica etc. potranno mai competere con giganti quali Russia, Cina, Brasile, India e perchè no, Turchia?
Se pensiamo però alle Istituzioni, siano Stati, Chiese, Ong o quant’altro come a delle persone, con un loro carattere ed un vissuto proprio, possiamo guardare a questi tempi come ad una crisi di mezza età. La Comunità, superati i suoi 50 anni si trova in un momento di riflessione, il fratello maggiore (gli Stati Uniti) che ha obbedito ed emulato per tempo, è troppo impegnato a risolvere i suoi problemi e -dicono i maligni- sembra più interessato a qualche bella asiatica che alla sorella minore. La passione della giovinezza sembra svanita, mentre il peso della maturità sembra schiacciante, disintegrante appunto.
L’Europa ha dimostrato però la grande potenzialità che la cooperazione può generare (l’Unione fa la forza), l’ideale di fratellanza, prosperità, libertà che ha incarnato per decenni, sono un modello che, da un continente che ha inventato il colonialismo, le dittature i campi di sterminio etc., non sembrerebbe proprio da buttar via. Le crisi si sà, sono un momento di trasformazione, non ci rimane che sperare , che quella attuale si tramuti in un’opportunità di rinnovamento, magari nuovamente di apertura, d’altronde quello è il suo passato (anche molto recente). Gli aspiranti (Turchia in testa) potrebbero davvero rilanciare e dare forza un progetto di unione di popoli e di culture, capace di fronteggiare le sfide di un presente sempre più complesso.
Archiviato in Uncategorized
La Repubblica Turca di Cipro Nord

Questa Repubblica si autoproclamò indipendente nel 1983, fatto che provocò la divisione dell’isola in due parti amministrative, Cipro e RTCN, quest’ultima viene riconosciuta ufficialmente dalla sola Turchia . La sua nascita è strettamente legata alle decennali frizioni fra Ankara ed Atene, risalenti allo smembramento del defunto Impero Ottomano. Nel 1974 la Grecia rilanciò la parabola della “Grande Idea” ossia il progetto, fallito con il Trattato di Losanna, di irredentismo/espansionismo dei territori abitati da genti elleniche e tentò di annettere l’isola attraverso un colpo di Stato, che rimuova il presidente Makarios a favore di Sampson; Makarios ritornerà poi in patria grazie all’esercito turco, sancendo il fallimento delle mire greche. La Turchia, che ha una nutrita diaspora sull’isola e che inoltre la considera troppo strategica per i suoi interessi commerciali e di difesa, decise di intervenire militarmente ed occuparla, causando l’esodo di oltre 200 mila greco-ciprioti . L’intervento militare è stato giudicato dagli stessi turchi come legittimo, in base al Trattato di Garanzia del 1960 (firmato da Turchia, Grecia e Regno Unito), dove all’art. IV è espressamente prevista la possibilità di intraprendere azioni per ripristinare lo status quo, attraverso operazioni multilaterali, o se ciò non fosse possibile, anche unilateralmente . Bisogna ricordare, inoltre, che l’intervento greco non era considerabile un “fulmine a ciel sereno” ma le tensioni sull’isola covavano almeno dal 1963, anno in cui scoppiarono violenti scontri inter-comunitari in tutta l’isola, sedati dall’invio di forze armate di Regno Unito, Turchia e Grecia (poi sostituite dalla missione Onu UNFICYP). Da quel momento la gestione politico amministrativa dell’isola passò di fatto nelle mani della popolazione greco-cipriota, trasformando Cipro in un regime, dove la minoranza turca vede limitati i propri diritti costituzionali, quale a titolo d’esempio, la partecipazione alla vita pubblica. A queste accuse, la popolazione greco-cipriota rispose che i turchi avessero volontariamente abbandonato ogni posizione amministrativa, con la volontà di crearne delle proprie autonome e che quindi il loro intervento, fosse atto a garantire la piena efficienza della macchina statale. Nel 1967 la Turchia, rispondendo ad un pogrom nel sud dell’isola, che aveva causato 27 morti fra la popolazione turca, reagì bombardando le postazioni dell’esercito greco e dichiarando l’instaurazione di una propria amministrazione provvisoria . Il presidente Makarios dichiarerà da subito illegale tale amministrazione ma, dopo questi avvenimenti, fra la gente dell’isola divenne chiaro che la popolazione turca dovesse godere di una limitata autonomia amministrativa. Tra il 1968 ed il 1970, grazie ai buoni uffici del Segretario Generale dell’Onu, vennero avviati quattro round di discussione per risolvere la disputa ma senza ottenere risultati evidenti. Ci si limiterà a riconoscere la situazione sul campo, a dichiarare il cessate il fuoco ed ad istituire la “linea verde” (United Nations Buffer Zone in Cyprus), che lasciò il 36% dell’isola sotto il controllo dell’esercito turco.
L’Onu ha sempre condannato l’intervento turco del 1974, ricordando che ogni intervento militare deve essere approvato dal Consiglio di Sicurezza, così da classificarlo come azione giustificata dalla volontà di reinstallare la pace e la sicurezza internazionale, in risposta a minacce alla pace, alla violazione della pace o ad atti di aggressione. Vengono prodotte due risoluzioni, la n. 541 che chiarisce il non riconoscimento del nuovo Stato e che anzi questo stia danneggiando gli sforzi per giungere ad accordi risolutivi e la n. 550, che condanna lo scambio di diplomatici fra Turchia e leadership turco-cipriota . Nel 1984 riaprirono le discussioni per la risoluzione della disputa, riducendo al 29% la porzione di territorio in mano turco-cipriota e sancendo l’abbandono dell’isola da parte di tutti gli eserciti stranieri. Nel 1988 venne convocata la conferenza di Ginevra dove, grazie all’intermediazione del Segretario Generale dell’Onu Perez De Cuellar, si incontrano i presidenti delle due parti George Vasiliou e Rauf Denktaş. L’unico accordo che si raggiunse in tale sede fu l’abbandono del Draft Framework Agreement, proposto nel 1986 dall’Onu, che prevedeva la creazione di uno Stato in Cipro indipendente, non allineato, bi-comunitario e diviso in due zone, per ritornare ai c.d. “High Level Agreements” del 1979 . In questa fase, le negoziazioni si bloccarono soprattutto per opposizione della minoranza turca al progetto di adesione dell’isola alla Comunità Europea, proposta dai greco-ciprioti. Nel 1990 la CE accettò la candidatura cipriota, scatenando la reazione di Ankara che firmò un accordo congiunto con la RTCN, istituendo un’unione doganale ed abolendo l’obbligo di passaporto fra i due Stati. Nel 1994 salì la tensione internazionale, dopo che il Consiglio Europeo di Corfù confermò l’inclusione di Cipro nel programma di allargamento della Comunità, e dopo che la Corte Europea di Giustizia impose l’embargo dell’export verso la RTNC e che la Grecia riescì a bloccare il progetto di unione doganale fra Ankara e Nicosia Nord .
Il 2002 sembrò essere l’anno propizio per una riconciliazione: alle due parti venne presentato il cosiddetto piano “Annan” (dal nome del Segretario Generale dell’Onu del momento Kofi Annan), che venne accettato dalle due parti nella versione rivista Annan II e, sempre in quest’anno, si svolse il consiglio Europeo di Copenaghen dove la Turchia sperò di trovare un accordo per accelerare il proprio percorso di adesione all’Unione Europea . Contestualmente, però, non avvenne lo sperato incontro fra i presidenti delle due parti, perché Denktaş si rifiutò di parteciparvi adducendo motivazioni di salute (era reduce di un intervento al cuore); mentre Cipro ottenne che il primo maggio 2004 sarebbe entrata a pieno titolo nell’Ue.
Tra il 2002 ed il 2004 Kofi Annan continuò la sua azione diplomatica, visitando l’isola una volta e facendo incontrare le parti a New York ed in Svizzera e modificando altre tre volte il piano Annan. Nella sua ultima versione il piano prevedeva la federazione di due Stati in un modello bicamerale, secondo cui ognuno avrebbe mantenuto un proprio parlamento ma una seconda camera congiunta avrebbe trattato le questioni federali. Per rendere operativa tale soluzione, questa sarebbe dovuta essere accettata simultaneamente da entrambe le parti attraverso un referendum, che si svolse il 24 aprile del 2004: la parte greco-cipriota votò per il no al 75,8 % mentre i contrari dall’altra parte furono solo il 35%; il voto finale sancirà la vittoria del no con il 68% di voti .
Nel 2008 arrivarono nuovi segnali di distensione, quando alle elezioni presidenziali della Repubblica di Cipro vinse Dimitris Christofias, a scapito del suo predecessore Papadopoulos, presentandosi come disponibile a riaprire i negoziati per la riunificazione dell’isola; i leader di entrambe le parti si incontrarono il 21 marzo presso la “buffer zone” Onu rilanciando discussioni approfondite a sancendo la nuova era di relazioni più distese, con la decisione di riaprire la strada Leda, chiusa dagli scontri dei ’60 (riaperta ufficialmente in presenza delle autorità di entrambe le parti il 3 aprile) . Si decise di formalizzare incontri regolari di natura tecnica e già a maggio dello stesso anno si erano svolti ben due meeting ufficiali; nel luglio le parti sembrarono addirittura accordarsi sul principio di un singolo Stato con un’unica cittadinanza. Ciò nonostante si presentarono altri due ostacoli al processo di riunificazione: la Turchia bloccò una nave cipriota per l’esplorazione petrolifera nel 2009 (operazione plaudita dal leader turco-cipriota) mentre nel 2010 vinse le elezioni della RTCN il nazionalista Derviş Eroğlu (anche se questo si è recentemente dichiarato favorevole all’opzione stato federale) .
Nel giugno del 2010 si raggiunse una nuova impasse ed i due leader vennero richiamati dallo special advisor Onu Alexander Downer a decidere sulla riunificazione o meno .
Archiviato in Turchia
La Turchia e l’Unione per il Mediterraneo
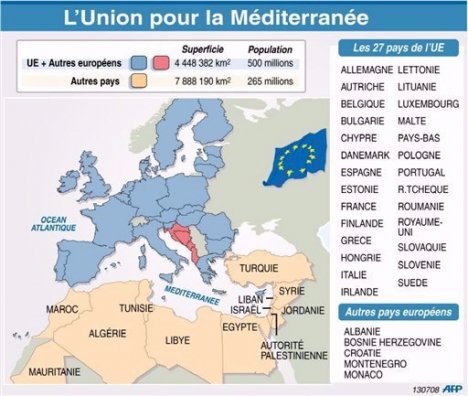
Come abbiamo visto la Francia, soprattutto dopo l’elezione a presidente di Nicolas Sarkozy, è fra i paesi più contrari al concedere lo status di membro dell’Ue alla Turchia; ciò nonostante, Parigi non esclude che l’Europa debba intrattenere relazioni solide con i paesi a lei prossimi, soprattutto quelli mediterranei. Questa posizione divenne evidente nell’ottobre del 2007, quando il presidente francese nel “discorso di Tangeri”, rilanciò l’idea di una “Unione per il Mediterraneo”, presentata come strumento per dare nuovo slancio alle relazioni fra l’Unione ed i suoi spazi prossimi nell’est e nel sud del Mediterraneo . Nel dicembre dello stesso anno a Roma, José Zapatero, Nicolas Sarkozy e Romano Prodi firmarono un accordo che rimetteva in moto il processo di avvicinamento euro-mediterraneo. Il 13 marzo 2008 il Consiglio Europeo approvò ufficialmente il progetto e cominciarono ad essere intrapresi i lavori preliminari; dal luglio dello stesso anno la presidenza di turno dell’Unione Europea spettò al presidente francese, che si adoperò per un vertice a Parigi il 13 ed il 14 luglio, istituendo così la nascita dell’Unione .
La paternità di tale iniziativa risale al cosiddetto “Processo di Barcellona” quando, nel 1995, i 15 Stati membri dell’Ue ed alcuni paesi mediterranei ipotizzarono la creazione di una zona di libero scambio. Il momento non sembrava però allora essere propizio, con la regione mediorientale surriscaldata (come dimostra l’assassinio di Rabin poche settimane prima ed in seguito lo scoppio della seconda intifada ). Alcuni hanno tacciato la proposta francese come strumento messo in atto per ostacolare il percorso di Ankara alla “full membership”, opinione sicuramente vera in parte, ma che offusca le altre vocazioni di tale progetto .
Nelle parole di Sarkozy la zona di libero scambio dovrebbe permettere di “fare del Mediterraneo il più grande laboratorio al mondo di co-sviluppo […], dove si costruisce e gestisce assieme la libertà di circolazione delle persone, e dove si organizza e si garantisce assieme la sicurezza”. Nel luglio del 2008 questa proposta vide le prime adesioni con il lancio a Parigi del primo incontro dell’Unione per il Mediterraneo (UPM); vi parteciparono i rappresentanti di 43 Stati (i 27 dell’Ue più tutti i paesi mediterranei esclusa la Libia che preferì lo status di osservatore ). La diplomazia francese lo presentò come forum dove tutti i partecipanti hanno ugual peso, e dove la Francia non avrà nessun pregiudizio verso chicchessia, siano anche leader autoritari e/o dittatoriali. Queste premesse si discostarono fortemente dalla linea umanitaria e pro diritti umani, che ha da sempre caratterizzato la presidenza Sarkozy, e diventarono dati di fatto, se si nota la presenza del presidente siriano Bachir El-Assad, persona non gradita in Francia da quando, nel 2004, le relazioni bilaterali con Damasco hanno toccato i minimi storici .
La Turchia vi prende parte come membro a pieno titolo ma, già dal gennaio 2008, il Primo Ministro Erdogan sottolineava che questa non viene considerata come un’alternativa al processo di integrazione alla Ue, impostando una partecipazione turca più osservatrice che partecipativa . In ogni caso, questa nuova cornice diplomatica venne di certo percepita positivamente da Ankara, che vide prospettive di azione politica di più ampio respiro rispetto a quelle legate alla sola Europa ed al contesto franco-turco. Inoltre, essendo presentata come “un’unione di progetti” con il fine ultimo della cooperazione (e quindi non di una nuova Unione fra Stati) tale iniziativa rassicurava la Turchia di non essere stata relegata in una sorta di Unione di serie B. Per queste ragioni sinora Ankara ha deciso di giocare una strategia di attesa, aspettando le mosse, soprattutto francesi in seno all UPM e degli altri Stati membri. Infatti tale organizzazione non è ancora pienamente strutturata ma anzi vive (o meglio rivive) ogniqualvolta uno degli stati membri lanci una qualche iniziativa ; in linea di principio la Turchia potrà giocare un ruolo strumentale importante, lanciando cooperazioni settoriali nel campo energetico, delle politiche migratorie, di difesa e nella questione israelo-palestinese.
Ritornando alla vexata questio dell’integrazione di Ankara nel club europeo, rimangono da esaminare due punti spinosi dove risiedono le maggiori frizioni fra Unione e Turchia : la questione della Repubblica Turca di Cipro Nord e lo sbilanciamento di potere nelle relazioni commerciali fra Turchia ed Unione Europea.
Archiviato in Turchia
Turchia in Europa: una maratona ad ostacoli
Cronologia Ragionata
L’annosa questione dell’ingresso della Repubblica turca all’interno dell’Unione Europea può essere fatta risalire addirittura al 1959, a due anni dalla creazione della Cee, quando con richiesta ufficiale Ankara si proponeva come candidata alla piena membership. Siamo in un momento storico cruciale di confronto fra il blocco occidentale della Nato e le repubbliche socialiste e, in tale frangente, si può ipotizzare che l’ingresso della Turchia nell’Alleanza Atlantica nel 1952 fosse un buon biglietto da visita per il paese .
In questi primi anni, la Comunità sembrò per lo più orientata ad allargare i propri confini sino alla penisola anatolica; già nel 1963, tramite il trattato di Ankara, venne prospettato un percorso per fasi: il primo passo sarebbe stato l’unione doganale, l’ultimo la piena adesione subordinata al raggiungimento di parametri politico-istituzionali in linea con quelli comunitari, quali una democrazia compiuta ed il rispetto dei diritti umani; dopodiché gli Stati membri avrebbero esaminato la possibilità di adesione .
Nel 1964 venne siglato un accordo di associazione, che preparava l’unione doganale, che diverrà poi effettiva dal 1996. Nel novembre del 1970 Turchia e Comunità Europea firmarono un ulteriore accordo, chiamato Protocollo Aggiuntivo, nel quale vennero stabilite delle date di scadenza per abolire gradualmente quote e tariffe (con qualche eccezione) sugli scambi commerciali fra i due mercati; vi si prevedeva, inoltre, la possibilità di libero movimento delle persone fisiche da entrambe le parti, in un arco di tempo compreso tra i dodici ed i ventidue anni . Tre anni più tardi il Protocollo Addizionale entrò in vigore, definendo le modalità per la futura unione doganale.
Tra il 1979 ed il 1980 la presidenza della Cee dichiarò a più riprese di non considerare il veto greco come un ostacolo insormontabile al percorso turco, ma già nel 1981 sospense i protocolli finanziari ed ignorò che, all’interno del programma Meda, vi fossero aiuti allo sviluppo diretti alla Turchia, la quale non venne nemmeno compensata per questi ammanchi. Procedeva, invece, il capitolo dei dazi doganali, con la decisione del giugno 1980 da parte del Consiglio di Associazione di ridurre a zero le tariffe sui prodotti agricoli entro il 1987 .
Nella prima metà degli anni ottanta, le relazioni entrarono in uno stato di “congelamento virtuale” dovuto al fatto che la Turchia, nel 12 settembre del 1980, si ritrovò ad essere soggetta ad un colpo di stato da parte dell’esercito .
Con il 1987 Ankara rinnovò la sua richiesta di adesioneall’Unione Europea, incassando nuovamente una risposta ambigua: la Commissione, infatti, sostenne che prima del 1992, per ragioni interne, non sarebbe stata in grado di esaminare qualsivoglia proposta di candidatura; Bruxelles, inoltre, sottolineò gli ostacoli che la separavano dalla Turchia, aggiungendo alle questioni di cui sopra, anche fattori economici quali differenze strutturali, bassa protezione sociale, ecc., e, soprattutto, la questione politica delle forti frizioni con uno Stato membro: la Grecia .
In questo ambito si ripropose l’idea di avanzare nelle relazioni bilaterali attraverso l’unione doganale e di post-porre (ad un futuro incerto) la questione dell’adesione; si può sottolineare come in tale fase si siano sollevate questioni solamente di carattere politico ed economico, mentre la questione culturale e religiosa viene del tutto taciuta dall’Unione.
L’unione doganale ha avuto sicuramente molti effetti benefici per la Turchia, oltre che sul piano economico anche su quello politico istituzionale (sempre nella speranza di un’apertura politica di Bruxelles); in questo senso, l’eliminazione dei dazi per le importazioni dall’Europa ha contribuito non poco all’industrializzazione del paese, ma anche alimentato le perplessità di Ankara, come vedremo nel paragrafo dedicato alla questione. Sul piano politico, poi, i valori europei di democrazia e diritti umani hanno provocato l’abolizione della pena di morte in tempo di pace ed alcune riforme costituzionali miranti ad una maggiore apertura democratica del paese .
Questa incertezza sulla piena integrazione ha alimentato un vivace dibattito presso gli euroscettici turchi, che sottolineano quanto sia stata sfruttata dall’Unione per mantenere il loro paese all’interno di un’orbita di interesse europea: per un verso, senza porre precise scadenze e, per un altro verso, ponendo forti freni a qualsivoglia iniziativa diplomatica di ampio respiro .
Con il 1997 le relazioni bilaterali conoscono un forte raffreddamento. Al Consiglio Europeo di Amsterdam del 16-17 giugno, infatti, la Commissione sottoponeva al successivo Consiglio di Lussemburgo un piano di allargamento a cinque nuovi membri ritenuti idonei per coesione e stabilità politica: Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Estonia e Slovacchia (oltre a Cipro la cui candidatura era già stata approvata in precedenza); sarà la Francia a scatenare le vive proteste di Ankara con la proposta di una fumosa Conferenza europea per gli aspiranti membri priva di ogni vincolarietà, alla quale il ministro degli esteri turco risponderà, senza mezzi termini, che “l’appartenenza alla Ue non rappresenta più l’obiettivo prioritario della politica estera turca” , respingendo con sdegno la partecipazione del proprio paese. A ciò si aggiunga l’ennesima esclusione della Turchia anche dal secondo gruppo di paesi candidati, la Lituania, la Bulgaria, la Lettonia, la Slovacchia e la Romania e si consideri, infine, la vicenda relativa al vertice di Cardiff del 1998, sotto la presidenza britannica, dove si discuteva sulle diverse opzioni per tempi e modi di futuri allargamenti dell’Unione e nel quale l’unica regione candidata, esclusa da ogni fase negoziale futura, era la penisola anatolica . In questo frangente il direttore del ministero degli esteri turco, Onur Oymen, espresse grave preoccupazione per la calata di nuova “cortina di ferro” culturale e religiosa in Europa, progetto politico immaginato per avvicinare i popoli e che, invece, sembrò chiusa a riccio su se stessa, dimentica dei principi di tolleranza e pluralismo alla base della sua esistenza. Molti altri analisti suoi connazionali esprimono frustrazione riassumibile nella frase: “avremmo avuto un trattamento migliore se invece di orbitare all’interno della Nato fossimo stati una dittatura comunista” .
Con l’Agenda 2000 del luglio 1997 la Commissione, presieduta da Jacques Sarter, pose l’accento sul fatto che, essendo terminata la fase storica della guerra fredda, non potrà più tollerare, nel nome dell’anticomunismo, il sostegno a dittature militari come quelle sudamericane o situazioni simili qual’è il caso turco; segue a ruota l’europarlamento che con propria risoluzione sostiene l’indisponibilità alla trattativa con qualsivoglia regime militare. Ankara, frustrata da un atteggiamento c.d. di “due pesi due misure”, ricordò il precedente dell’ammissione greca del 1981, nonostante le trattative fossero state avviate durante il regime dei colonnelli, riconosciuto dall’intera comunità internazionale come pesantemente coinvolto in violazioni di diritti umani .
Proprio dalla Grecia, però, in quel momento storico ricordato come “la diplomazia dei terremoti”, arrivarono segnali distensivi: il ministro degli esteri Ghiorgos Papandreu al Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 dialoga con il suo omologo turco Ismail Cem sulla volontà greca di eliminare qualsivoglia veto all’ingresso di Ankara, se si fosse calendarizzato con certezza l’avvio dei negoziati per l’entrata della repubblica di Cipro . Atene, inoltre, costituì un gruppo di lavoro composto da alti funzionari del proprio ministero degli esteri, al fine di aiutare i colleghi turchi a recepire l’acquis comunitario .
Nel 2002, alla vigilia del Consiglio europeo di Copenaghen di dicembre, si respirò aria di distensione. Da parte turca, il nuovo governo guidato dell’AKP per nome del primo ministro Abdullah Gul riconfermava la priorità dell’Unione all’interno della propria politica estera, in un articolo apparso su Le Monde: “ La Turchia, a causa della sua storia della sua geografia e del suo sistema di valori, agisce e reagisce da europea. Essa aderisce ai valori europei al termine di un processo di adattamento durato tre secoli. (…) È un elemento chiave della difesa e della sicurezza europee. La Turchia è un modello che unisce la sua identità con la modernità, l’islam con la democrazia laica, lo Stato sociale con la via del diritto. (…) Integrando la Turchia come membro, l’Unione farà valere la credibilità dei valori che costituiscono il suo fondamento, quali la tolleranza etnica, il rispetto delle religioni e delle culture. Le inimicizie storiche saranno relegate al passato” .
Da parte occidentale invece, l’autorevole ed influente testata “The Economist”, forse anche sulla spinta dell’incerta situazione internazionale post 11 settembre, sottolineava la necessità dell’ingresso di Ankara come messaggio di apertura e tolleranza a tutto il mondo islamico, da non giudicare come incompatibile con la democrazia , in concomitanza con le esplicite pressioni dell’amministrazione Bush per accellerare il percorso di adesione turco .
Con il summit di Copenaghen l’Europa sembrò avvicinarsi: alla Turchia si diedero due anni, sino a dicembre del 2004, per implementare le proprie riforme in vista di un tavolo negoziale per il suo accesso , dopo decenni di incertezza sembrò profilarsi finalmente una data certa, con l’aggiunta di una decisa sponsorizzazione statunitense.
Nel 2003 sempre per volontà greca, Gul partecipò agran sorpresa al vertice informale dei ministri degli esteri dell’Ue del 2-3 maggio, quando il panfilo su cui si svolse il meeting approdò nel porto turco di Kaç con un abile colpo di teatro della diplomazia ellenica ; la Turchia sembrò – per un attimo – pienamente accettata nella “famiglia europea”.
Da parte di Ankara, in quell’anno, il messaggio più forte verso l’Ue fu la ratifica del parlamento turco del “Seventh Adjustment Package” dei criteri di Copenaghen. Per la prima volta nella storia della Repubblica il ruolo dei militari venne formalmente compresso, limitando il potere esecutivo e le aree di intervento del Consiglio Nazionale di Sicurezza, che vide inoltre accrescere al suo interno la porzione dedicata a civili, e ponendo sotto il controllo della Corte dei Conti il budget militare, sino a quel momento segretato .
Nel 2004, invece, l’attenzione si spostò sulle riforme costituzionali, approvate il 7 maggio, in base ai criteri stabiliti nel Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2003. Tali riforme compresero: la modifica del sistema giuridico, l’ampliamento della libertà di stampa, si introdusse il concetto di parità di genere, ecc.
Nel dicembre del 2004 l’Unione, riconoscendo i grandi sforzi turchi riguardo ai criteri di Copenaghen, decise di ufficializzare l’inizio dei negoziati per l’accesso nell’ottobre dell’anno successivo, con la clausola che Ankara estendesse gli accordi doganali contratti con l’Unione anche ai dieci nuovi stati membri fra cui figurava Cipro. La Turchia ratificò anche questo accordo ma precisò con una dichiarazione ufficiale che tale misura non significava in alcun modo riconoscere l’amministrazione greco-cipriota ; iniziò, quindi, il processo di negoziaziato vero e proprio, atto a verificare il recepimento da parte turca dei trentacinque “Criteri di Riferimento” .
I lavori procedettero con una inconsueta lentezza: dal 2005 ad oggi si sono esaminati solo tredici dei criteri in questione, giungendo all’accordo solamente su uno di questi. Per fare un esempio si può ricordare che la Croazia ha iniziato i negoziati per l’ingresso nello stesso anno della Turchia, aprendo la discussione su trenta parametri e definendone diciassette .
Nel 2006 avvenne il primo stallo; nel mese di dicembre si decise di sospendere (quindi escludere provvisoriamente dal negoziato) ben otto parametri in vista di una soluzione alla questione cipriota. Sui restanti, dalla parte dell’Unione si insistette sulla complessità degli adeguamenti necessari per conformarsi all’acquis comunitario, mentre la Turchia, ricordando che la procedura di screening del suo sistema legislativo fosse stata già compiuta da ben otto sottocommissioni turche negli ultimi quattro anni, lo considerava una “perdita di tempo” ed, addirittura, pose la questione della sincerità della Ue, quando nel 2009 il presidente Gul dichiarava: “Opporsi all’adesione significa violare decisioni che sono già state prese […] Questo significa che la decisione di aprire le negoziazioni con la Turchia non è stata sincera, che i capi di stato hanno preso una decisione che non riflette le loro vere intenzioni” . Sulle obiezioni alla politica economica turca, presentata da alcuni critici come non di mercato, lo stesso presidente (a quell’epoca ancora ministro), utilizzò la ricorrente carta giocata dalla diplomazia turca del double standard, chiedendosi: “I paesi che entreranno nell’Ue nel 2007 sono economie di mercato più sviluppate della nostra?” . In realtà, alcuni osservatori fanno notare che le critiche all’economia turca risiederebbero non tanto sull’eccessivo intervento statale, ma bensì sull’ampiezza del suo settore agricolo: con l’ingresso nell’Unione questa potrebbe drenare gran parte dei fondi Cap (Common Agricolture Policy) e beneficiare di altri, quali quelli regionali e sociali. In breve il suo contributo al budget comunitario potrebbe risultare inferiore ai fondi incamerati .
Nel 2007 si inserì un nuovo ostacolo, questa volta puramente politico, al percorso di adesione. Il presidente francese Nicolas Sarkozy, oltre ad affermare più volte la sua contrarietà all’ingresso turco, disse infatti che la Francia porrà il veto su cinque parametri decisivi per la membership di Ankara. Il capo del governo francese dichiarò: “Il fatto di allargare l’Europa senza limitarsi rischia di distruggere l’unione politica europea, ed io non lo accetto […] Voglio dire che l’Europa deve darsi dei confini, che non tutti gli stati hanno una vocazione a diventare membri dell’Europa, iniziando dalla Turchia che non ha spazio all’interno della Ue” . Da parte francese, si deve inoltre aggiungere il timore che l’allargamento ad uno Stato a maggioranza musulmana possa contribuire all’immigrazione massiccia verso il paese di persone di fede islamica, che andrebbero ad aggiungersi alla già nutrita comunità residente. Sul fattore cultural-religioso si basa anche l’opposizione alla Turchia dell’Austria, che, ancorata al suo passato, quando tendeva a rappresentarsi come il muro difensivo dell’Europa cristiana contro l’avanzata dell’Impero Ottomano, ripropone tutt’oggi il mito di un’Europa cristiana minacciata da “infedeli invasori”.
Questo blocco alle trattative va ad aggiungersi ad altri due strettamente legati fra loro: il primo da parte dell’Ue, il secondo proveniente da Cipro; infatti, da parte turca non è mai caduto il divieto per la repubblica cipriota di utilizzare i suoi porti ed aeroporti, sino al giorno in cui l’Unione a ventisette non si decida a rompere l’isolamento diplomatico della Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconoscendola come legittima.
Ancora nel 2007, la Commissione dichiarò che la candidatura turca si potrebbe concludere nel periodo 2007-2014, posticipando almeno al 2014 la questione dell’adesione.
Se la piena adesione rimane l’unico obiettivo ufficiale di Ankara, da più parti (istituzionali ed accademiche) sono comunque emerse proposte e progetti per avvicinare la Turchia all’Europa, senza accoglierla nella “famiglia” comunitaria. Nei prossimi post ne presenteremo alcuni.
Archiviato in Turchia
Il Mercato: un Bene Comune?
Ad oggi gli Stati sono dovuti intervenire, volenti o nolenti, all’interno delle rispettive economie, nel tentativo di tamponare quella che viene ormai definita, la più grave crisi dai tempi della Grande Depressione.
Il solo intervento dello Stato però, non prefigura un ritorno alle politiche Keynesiane, la nostra domanda di fondo, ma segna a detta di molti, come lo Stiglitz che arriva a paragonare la caduta di Wall Street a quella del muro di Berlino, la fine di un’era improntata all’antico concetto di capacità auto-regolamentatrice del mercato.
Il venir meno di un approccio ideologizzato alle questioni economiche, è una prima precondizione per chi si auspica un ritorno alle teorie di Keynes; su questo punto sarà necessaria una forte riflessione politica, visto che le forze più rappresentative, sia di sinistra sia di destra, sembravano convergere su molti punti dell’ideologia del laissez faire.
L’assenza di regole nei mercati, è vista ormai dalla stragrande maggioranza degli esperti, come uno dei fattori scatenanti alla base dell’attuale crisi. Le classi dirigenti quindi, dovranno ed ora potranno, visto il mutato clima culturale, sviluppare sistemi di controllo dei meccanismi di mercato, soprattutto nella sfera finanziaria.
Esistono, inoltre, altri elementi che minano un equilibrato sviluppo economico e sui quali lo Stato, rimanendo fedele al dettato di Keynes, può intervenire.
Innanzitutto, si dovrebbe tornare a meccanismi ridistribuivi del reddito nazionale, più equilibrati.
Nel caso italiano, ad esempio, troviamo che il 60% delle famiglie ha un reddito inferiore a quello medio; sempre rimanendo all’Italia, il suo prodotto interno, espresso in termini reali, è cresciuto dal 1992 al 2006 del 16,8%; di questi, solo il 2,2% (pari al 13% sul totale) è stato destinato ai lavoratori, mentre degli altri 14,5 punti (87% sul totale), hanno beneficiato le imprese. Ciò significa, che gli aumenti di produttività del sistema paese, sono andati quasi esclusivamente ai profitti ed alle rendite, comportando una forte compressione salariale e quindi, un progressivo impoverimento delle fasce basse della popolazione, quelle con la più alta propensione al consumo.
Per meglio comprendere le dinamiche ridistributive italiane, riportiamo di seguito alcuni grafici, elaborati sulla base di dati Ocse ed estrapolati dal recente articolo del Perri, a cui rimandiamo per un commento alle statistiche.
Per una lettura confortevole dei grafici con un click sopra l’immagine, questa si aprirà in una nuova finestra.
Nel Grafico 1, è visibile l’aumento della diseguaglianza fra i paesi Ocse a partire dagli anni Settanta, caratterizzata dalla diminuzione della quota di retribuzione del lavoro sul reddito nazionale ed il pronunciato calo di questa in Italia.
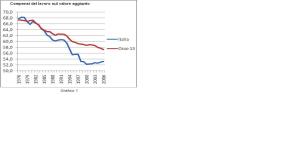
Nel Grafico 2, si nota che la quota del reddito nazionale italiana, che si ottiene attraverso il lavoro, è la più bassa tra i paesi che si stanno confrontando.

Nel Grafico 3, è rappresentato l’indice di concentrazione dei redditi, l’indice Gini. L’Italia risulta avere verso la metà degli anni 2000 un alto indice di Gini, inferiore solo a quello degli USA tra i paesi considerati e superiore alla media di 24 paesi dell’OCSE.

Nel Grafico 4, troviamo un confronto fra i redditi mediani ed i redditi medi, dei decili, sia più poveri, sia più ricchi della popolazione. L’Italia sia per il reddito mediano che per il reddito del 10% più povero è l’ultima tra i paesi considerati; sebbene ha redditi minori rispetto alla media OCSE, il reddito del 10% più ricco della popolazione, risulta più alto rispetto alla media OCSE.
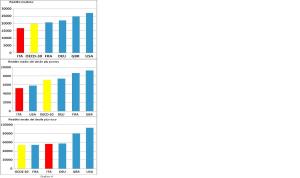
Nel Grafico 5, è riportata l’elasticità dei redditi fra generazioni; l’Italia è seconda solo al Regno Unito per immobilismo sociale.

Nel Grafico 6, vediamo l’efficacia ridistributiva dell’intervento pubblico; L’Italia presenta parametri inferiori alla media Ocse, paragonabili a quegli Stati dove non è sviluppato un sistema di welfare.

Sempre rimanendo in un’ottica ridistributiva, altro importante elemento d’azione nelle mani del Governo, è lo strumento fiscale; il nostro paese è gravato da una pressione erariale paragonabile agli altri Stati in zona euro, ma presenta alcune anomalie: alte aliquote sproporzionate al reddito ed una forte evasione fiscale.
Per questo, è urgente un’innovativa politica fiscale, che innalzi la tassazione sulle fasce a maggior reddito, le abbassi ai meno abbienti, ma soprattutto comunichi un rinnovamento culturale della classe dirigente, vista oggi come inefficiente se non addirittura corrotta.
L’azione governativa potrebbe seguire due direttive principali: la lotta all’evasione fiscale ed un tangibile miglioramento, sia in termini qualitativi sia in quelli quantitativi, dei servizi ai cittadini, tali da ricostruire un rapporto fiduciario fra cittadino e Stato così da giustificare la maggior pressione fiscale per i più ricchi.
Altra questione della quale lo Stato dovrebbe interessarsi, è quella del capitale umano; il “grande balzo” cinese, indiano e brasiliano si è fondato, non più sul raggiungimento di obiettivi produttivi del tutto sconnessi dal tessuto economico dei vari paesi (come lo fu quello lanciato da Mao Tse Dong, per sorpassare l’Inghilterra nella produzione di acciaio), ma sull’accumulazione, sia di competenze teoriche che tecnologie, che hanno permesso a questi paesi emergenti di competere con i quelli cosiddetti avanzati.
Stati come la Cina, la Corea del Sud, la Malaysia e Taiwan hanno conosciuto un grande sviluppo delle loro economie, basandosi su due principi: in primo luogo investire pesantemente in istruzione primaria e non ed in ricerca scientifica, in secondo luogo hanno scelto i settori industriali sui quali puntare (hi-tech), anziché lasciare la decisione al solo mercato.
Per l’Italia la questione è pressante, poiché il settore industriale pur favorito dalla politica ridistributiva, come già detto prima, non ha conosciuto un aumento del tasso di investimento, né una crescita in spese destinate all’innovazione e quindi un aumento della propria competitività. Inoltre il settore della ricerca scientifica, pur producendo ottimi ricercatori, è a dir poco sotto-finanziato e mal collegato al settore industriale, che per sua specializzazione si trova a competere con i paesi emergenti.
Per l’Italia quindi, si potrebbe proporre il ricorso alle politiche suggerite da Stiglitz e Greenwald, sulla infant economy: ricorrere a dosi di protezionismo, da limitarsi nel tempo ed ad settori industriali prescelti, per le esternalità positive che questi possono produrre per l’intero sistema paese, si pensi a mo’ di esempio alle innumerevoli ricadute in tutti i settori della società che ha l’innovazione, ma ciò significa quindi, riflettere sul fatto che non sempre i mercati funzionano bene e sulle capacità correttive dello Stato. Tale impostazione presenta però delle limitazioni, visto il nostro appartenere all’Unione Europea, di per sé avversa a meccanismi protezionistici. Inoltre i settori che in questo momento richiedono aiuti dallo Stato sono quelli tradizionali, mentre per un rilancio dell’economia reale sembrano oggi avere più importanza altri comparti, con particolare riferimento alla Ricerca e Sviluppo. Tale campo dal canto suo, richiede forti iniezioni di liquidità che, in Europa, potrebbero essere individuate nell’eccessiva mole di riserve di moneta ed oro, detenute dagli Stati membri e che con l’introduzione dell’euro hanno perduto la loro ragion d’essere; queste riserve quindi potrebbero essere convogliate in un ipotetico fondo sovrano europeo ed essere utilizzate se non direttamente per investimenti produttivi, come loro garanzia.
Archiviato in Economia
Turchia-Israele fra conflitto e cooperazione
Dalla WWII al Patto di Baghdad
Prima di concentrarci agli anni più recenti della relazione bilaterale fra Ankara e Tel Aviv – ricchi di avvenimenti straordinari e di contraddizioni – che produsse un vasto dibattito nel mondo scientifico, è utile dare uno sguardo al quarantennio 1950-1990, per poter comprendere a sommi capi l’ambiente internazionale in cui si svilupperà l’intesa fra i due Stati sbocciata nel 1996.
Innanzitutto, la Turchia sin dalla fine della seconda guerra mondiale percepì come ostile l’ingombrante vicino sovietico, con il quale esistevano dispute di confine, che soprattutto continuava ad avere mire sugli Stretti e che incoraggiava le mire siriane sulla regione di Hatay (causa prima del “divorzio” fra turchi ed arabi) . A queste pretese, Ankara oppose sempre un netto rifiuto, sperando, e poi – con la proclamazione della dottrina Truman nel 1947 – sapendo di non essere lasciata sola dalle potenze occidentali. Furono quindi le mosse diplomatiche dell’Unione Sovietica a gettare le fondamenta per l’allineamento turco all’Occidente, mentre lo schieramento arabo con l’Oriente, fu la conseguenza dell’atteggiamento dell’Ovest riguardo la questione palestinese . Il riconoscimento da parte turca di Israele il 19 marzo 1949 (il primo Stato Mediorientale a farlo) è da leggersi in tal senso; un importante funzionario del Ministero dell’Informazione spiegò tale vicenda: “Come se [la Turchia, ndr.] volesse enfatizzare il proprio occidentalismo ed il suo approccio obiettivo nell’area” .
Tra il 1951 ed il 1955 Stati Uniti e Regno Unito, considerando la repubblica kemalista un buon alleato utile a mantenere ordine nel Medio Oriente, la convinsero, sebbene riluttante vista la sua impostazione di politica estera basata sul principio dettato da Ataturk di concentrarsi solo sulla protezione dell’integrità territoriale, ad un maggior attivismo nell’area.
Il primo passo fu di inserire Ankara nel piano britannico (poi abortito) “Middle East Defence Organization (MEDO) nel 1951, per giungere alla firma del “Patto di Baghdad” nel 1955, che per la prima volta dal 1923 riallacciava i legami turchi con la regione . In questa fase gli Usa sembrano ancora equidistanti fra arabi ed israeliani, infatti sebbene il suddetto patto fosse una loro iniziativa per costruire un fronte anti sovietico, non si impegnarono aderendovi formalmente, così da non infastidire Egitto ed Israele, entrambi preoccupati che tale organizzazione avrebbe armato i loro rispettivi nemici .
La Turchia accolse favorevolmente la situazione poiché le permetteva di approvvigionarsi di armi moderne ed aiuti finanziari, anche se dal punto di vista diplomatico, dovette fare una concessione al suo alleato arabo Nuri al-Sa’id, presidente iracheno contrariato dalla partecipazione israeliana alla “crisi di Suez”, ritirando il proprio ambasciatore da Tel Aviv il 20 novembre del 1956 . Questa decisione ebbe un unico effetto “cosmetico”, Ankara si affrettò a comunicare alla controparte israeliana di voler continuare ad intrattenere relazioni amichevoli e la missione turca continuò la propria attività come nulla fosse successo, tramite il proprio chargè d’affaire mentre le relazioni commerciali fra i due Stati, di piccola scala ma comunque vantaggiose, rimasero invariate . L’attitudine turca di occidentalismo in salsa araba, divenne da subito impraticabile: nel 1957 aumentarono le frizioni con la Siria, nel 1958 con l’Iraq e nello stesso anno la concessione fatta agli Usa di far stazionare truppe NATO nella propria base di Adana (e quindi un appoggio logistico alla operazioni belliche durante la “crisi del Libano), fecero perdere qualsiasi credibilità di sostegno agli arabi da parte turca, creando malumori sia all’estero che in patria . Da questo momento Israele percepì Ankara come Stato amico, con il quale stringere una solida, ma riservata, alleanza militare inserita nel contesto della dottrina degli “Stati periferici”, ideata da Ben Gurion.
Ben Gurion e la strategia degli “Stati periferici”
David Ben Gurion, primo capo di Governo dello Stato di Israele tra il 1949 ed il 1963 (eccetto il periodo 1954-55), era consapevole del fatto che il suo neonato paese non avrebbe potuto per molto tempo stringere alcun tipo di relazione con gli Stati limitrofi (è sua la politica della rappresaglia verso quegli Stati che permettevano ai palestinesi di sconfinare in Israele ), sviluppò la strategia chiamata degli “Stati periferici” . Se i vicini arabi puntavano a strangolare nella culla il loro nuovo e non gradito vicino, questi rivolse le proprie energie economiche e diplomatiche per costruire legami con Stati non arabi ma comunque gravitanti nell’area mediorientale. In particolare i maggiori sforzi della diplomazia israeliana negli anni ‘50 furono rivolti verso Etiopia, Iran e Turchia. Questi paesi furono fra i primi a riconoscere la sovranità israeliana tra il 1949 ed il 1950, si trovano in posizioni geografiche diverse così da poter garantire a Tel Aviv vettori di influenza dal Nord Africa all’Asia Centrale e soprattutto non sono composti da popolazioni arabe (anzi conoscevano al loro interno una nutrita diaspora ebraica) e quindi non ostili di principio ad Israele. Sarebbe un errore però, sostenere che lo Stato ebraico ignorasse del tutto i propri vicini arabi, si possono collocare all’interno della strategia “periferica”, anche gli assidui contatti intrattenuti con le minoranze non arabe quali la comunità cristiana libanese, i ribelli del Sudan meridionale e la popolazione curda in Iraq .
Per quanto riguarda la Turchia, questa sarà l’ultimo tassello della strategia israeliana; i motivi per “corteggiare” Ankara, oltre a quelli già citati, erano molteplici: membro della Nato, la Turchia si avvicinò ad Yugoslavia e Grecia nel 1953, nella cosiddetta “Alleanza Balcanica”, che alcuni vedono come patto “apripista” a quello successivo fra lo Stato ebraico e kemalista .
Inoltre da parte turca giungevano segnali distensivi riguardo la popolazione ebraica residente nel suo territorio; quando nel settembre 1955 scoppiò la “crisi di Cipro” alcuni manifestanti ostili alla Grecia attaccarono diverse proprietà di ciprioti ebraici, il governo turco si precipitò a dichiarare: “Non abbiamo nessuna intenzione o inclinazione di pregiudicare in qualsiasi modo la sicurezza o i diritti degli ebrei di Turchia” . Ci vollero ancora tre anni perché iniziassero le trattative preliminari all’avvicinamento fra i due Stati. Si può sostenere che la Turchia fosse, in una prima fase, attendista; la creazione dello Stato ebraico avvenne così velocemente e fu così gravida di così tante conseguenze a livello regionale ed internazionale, da sconsigliare cordialità repentine. Un’accelerazione divenne necessaria quando nel 1958 nacque la Repubblica Araba Unita, dall’unione della Siria con l’Egitto; Damasco, storica alleata di Ankara venne percepita come filo-sovietica e quindi persa per sempre . Stesso timore si ebbe per l’Iraq quando nello stesso anno Abd al-Karīm Qāsim salì al potere con un colpo di stato (in questo caso ciò che fece salire la tensione fu lo schieramento di 24 divisioni sovietiche al confine iracheno) . Tra l’inverno e la primavera del 1958 si ebbero i primi contatti segreti fra la diplomazia israeliana e quella turca a bordo di una vascello navigante sul mar di Marmara; in aprile si giunse al primo incontro ufficiale fra l’ambasciatore israeliano Eliyahu Sasson ed il Ministro degli Esteri turco Fatin Zorlu, che aprì la strada ad un vero e proprio incontro al vertice – seppur segreto – fra i rispettivi Primi Ministri . Il 28 agosto del 1958 Ben Gurion dopo un incontro con i propri vertici di stato maggiore, lasciò il paese indossando la divisa militare con direzione Turchia . Quella stessa notte, si vocifera abbia incontrato in segreto i rappresentanti turchi, e siglato un’alleanza militare clandestina con Ankara, anch’essa in cerca di partner affidabili anche a causa degli scricchiolii in seno al Patto di Baghdad (l’Iraq ne uscirà nel marzo del 1959) .
Da parte statunitense, l’inclusione della Turchia nella strategia “periferica” di Israele, venne considerata in un primo momento con una certa freddezza, temendo forse che questa avrebbe contribuito, se ampiamente pubblicizzata, a gettare ulteriore benzina sul fuoco in un Medio Oriente già surriscaldato; il Presidente Eisenhower non volle mai avvallare ufficialmente questa mossa strategica di Tel Aviv, rifiutandosi di discuterne negli incontri bilaterali Usa-Israele . Le titubanze statunitensi non sembrano del tutto infondate: con l’avviarsi degli anni ’60 la situazione turca apparve traballante a causa di un’economia in crisi (gli aiuti Usa non bastavano per rilanciarla) ed il Partito Democratico, dominante per tutti gli anni ’50, perse di credibilità agli occhi dei militari (più vicini al Partito Repubblicano Popolare) che decisero di sciogliere ed imporre un proprio esecutivo nel marzo 1960 .
La “nuova politica estera” turca da Cipro a Rabat
In questo nuovo contesto di politica interna, la Turchia incominciò una riflessione sulla bontà o meno delle sue precedenti scelte in politica estera.
L’allineamento con gli Stati Uniti venne percepito come poco utile, oltre ai già citati scarsi aiuti economici, vi furono altri due eventi che instillarono il dubbio sulla convenienza di mantenere una linea fortemente filo-occidentale. Nel 1963 Washington prese la decisione unilaterale di rimuovere dal suolo turco la batteria di missili Jupiter, così da migliorare le relazioni con l’Urss, deterioratisi sino alla minaccia di una terza guerra mondiale con la crisi missilistica di Cuba dell’anno precedente; sempre nel 1963 il Presidente americano Johnson, scrisse una lettera al Primo Ministro Inonu avvertendolo che la NATO non sarebbe intervenuta in ausilio alla Turchia, nell’eventualità che la crisi cipriota avesse attirato le ire sovietiche . La politica di riavvicinamento alle posizioni arabe, ripresa nel 1960 quando la Turchia per la prima volta votò in seno alle Nazioni Unite con il blocco dei Paesi africani ed asiatici sulla questione algerina, per manifestare il proprio senso d’isolamento sulla sua posizione riguardo al Patto di Londra di cui abbiamo già parlato nel primo capitolo, trovò conferma nell’indifferenza che gli Usa stavano dimostrandole .
E’ in questa prospettiva – oltre alla prima comparsa ufficiale nell’arena politica di un sentimento religioso con il governo Demirel – che va letta la distensione dei rapporti con l’unione Sovietica; quest’ultima non venne più percepita come una minaccia imminente (sebbene ciò non significhi l’abbandono del blocco Occidentale) ma come l’alleato dei Paesi arabi con i quali si volevano migliorare le relazioni (e magari strapparne l’appoggio sulla questione cipriota), dopo le difficoltà degli anni ’50 .
Questa nuova impostazione di politica estera, improntata a massimizzare il suo duplice ruolo di Stato musulmano ed Occidentale, venne condotta in modo da non danneggiare i rapporti con Israele. Nel 1965 Ankara dichiarò che una sua partecipazione alla Conferenza Islamica di quell’anno sul conflitto israelo-palestinese sarebbe stata “utile”, ma poi rifiutò il piano proposto dal Sovrano saudita Faysal perché ritenuto poco equilibrato . Nel 1967 invece, durante il terzo conflitto fra Stati arabi ed Israele, la Turchia votò all’Onu per la posizione araba, si allineò con la richiesta di ritiro delle truppe israeliane alla linea antecedente il 5 giugno 1967, inviò qualche genere di conforto per la popolazione ma si rifiutò sempre di considerare le operazioni belliche dello Stato ebraico come “aggressioni” . Anche nel 1969 venne mantenuto da parte turca l’approccio basato sull’equidistanza fra arabi e popolazione ebraica, durante l’incontro marocchino a Rabat della Conferenza Islamica; la Turchia accettò di parteciparvi con un’agenda ristretta alle sole questioni politiche riguardanti i fatti della Moschea di Aqsa e lo status di Gerusalemme . In quella sede Ankara si dichiarò disponibile ad accettare senza riserve critiche ad Israele per non aver ottemperato alle risoluzioni ONU, ma che la critica non sarebbe mai passata al livello di “condanna”, e che si sarebbe rifiutata di discutere della questione palestinese, se non sul piano umanitario .
Il difficile rapporto con l’OLP
Con l’aprirsi del nuovo decennio, la Turchia conobbe nuovamente un periodo di instabilità economica e politica che si riflessero anche sulla sua condotta internazionale. Se fino al 1972 non si notano discordanze nella politica estera turca dall’impostazione scelta negli anni ’60, si pensi alla sua opposizione alla risoluzione ONU (A/PV.2114) riguardante il terrorismo internazionale (e quindi di condanna all’OLP dove gli Stati arabi votarono favorevolmente), con il 1973 l’atteggiamento di Ankara ebbe una decisa svolta pro-araba.
In quell’anno, quando scoppiò la quarta guerra arabo-israeliana, Ankara negò agli Usa l’uso del proprio territorio e delle sue infrastrutture militari per inviare soccorsi ad Israele, mentre concesse ai velivoli sovietici di sorvolarla, così che questi potessero assistere le operazioni belliche egiziane e siriane . Siamo ad un ribaltamento degli eventi rispetto al 1958, ora la Turchia partecipa agli eventi di guerra (sempre e solo con un appoggio di tipo logistico) sostenendo attivamente il fronte anti-israeliano. Tale impostazione, divenne ancora più evidente quando Ankara decise di dare voce e supporto alla causa palestinese all’interno delle Organizzazioni Internazionali. In particolare l’ONU, che in quegli anni sembrò muoversi gradualmente verso posizioni più filo-palestinesi quando li nominò all’interno della propria risoluzione (A/RES/3236) che invocava il diritto del “popolo di Palestina” ad avere “nazionalità indipendente e sovrana”, conobbe per tutto il 1974 l’attivismo pro OLP della Turchia. Questa votò favorevolmente la risoluzione suddetta, anche se non vi era alcun tipo di riferimento alla risoluzione 242 (S/RES/242), dove si riconosce il diritto a tutti gli Stati della regione Mediorientale, Israele inclusa, a vivere in pace; per questo motivo la 3236 vide l’astensione o il voto contrario di tutto il blocco Occidentale. Ancora più sorprendente fu il comunicato congiunto Turchia-Libia del 1975 dove si esprimeva: supporto agli sforzi per la causa palestinese ed il diritto degli Stati arabi a riappropriarsi dei loro territori occupati. Alcuni fanno notare che quest’ultima scelta avesse poco a che fare con la politica internazionale e molto di più con il petrolio; la Turchia infatti risentì pesantemente dell’aumento che l’ “oro nero” conobbe dal 1973 in avanti e vide nella Libia, ricca di tale risorsa, un partner commerciale da corteggiare (con Tripoli si accordò anche per l’invio di 600.000 lavoratori turchi, finita ormai la domanda di forza lavoro dall’Europa) .
Sebbene possa apparire paradossale, il sostegno di Ankara verso la causa palestinese era accompagnato da un certo fastidio verso l’OLP; questi era riconosciuto sul piano formale come il “solo e legittimo rappresentante delle popolazioni arabe di Palestina” ma il riconoscimento pratico, e quindi la concessione di poter aprire un ufficio di rappresentanza ad Ankara, arrivò solo nel 1979, ben tre anni dopo aver preso tale impegno presso la VII Conferenza Islamica dei Ministri degli Affari Esteri, tenutasi proprio ad Istanbul . Le cause sottostanti i malumori turchi verso l’OLP erano molteplici: tale organizzazione addestrò militanti turchi all’interno delle sue fila e, cosa ben più grave agli occhi di Ankara, l’OLP sembrava collegata ad altri movimenti separatisti quali quelli curdi . Non dobbiamo poi dimenticare che in questi anni la strategia per la liberazione della Palestina cambiò radicalmente, passando dall’attacco ad obiettivi militari allo stragismo sanguinario . Inoltre l’OLP si schierò contro la posizione turca sulla questione cipriota (denunciandone l’aggressività e sostenendo che l’esercito turco non avesse alcun diritto di stazionare sull’isola) quando non approvò la risoluzione della VII Conferenza Islamica, che sosteneva le tesi turche .
Dopo aver esaminato i punti di frizione fra Turchia ed OLP, resta da spiegare come fu possibile che tale organizzazione aprisse un proprio ufficio ad Ankara. Oltre al già citato impegno presso la Conferenza Islamica, si verificarono sia avvenimenti di carattere nazionale sia internazionale, che premettero in quella direzione; sul piano interno il governo Demirel, favorevole e collaborativo verso il viaggio che Saddat compì alla volta di Gerusalemme nel 1977, vide la forte opposizione da parte della minoranza parlamentare guidata da Erkeban (a guida del Partito della Salvezza Nazionale, di stampo religioso e su posizioni pro-arabe) che condannava la visita del Presidente egiziano. Questo scontro, durante un periodo di instabilità politica palpabile, modificò la posizione di allineamento con l’Ovest di Demirel, in un appoggio alle posizioni arabe da parte del nuovo governo guidato da Ecevit, che nel 1979 si oppose sia agli Accordi di Camp David sia alla pace stipulata fra Egitto ed Israele, perché non menzionavano la questione palestinese . In aggiunta quell’anno un gruppo di militanti palestinesi occupò l’ambasciata egiziana in Turchia, l’OLP prese le distanze dall’evento e si propose come mediatore, accettato sin da subito dal governo turco; la crisi si risolse in tempi brevi ma soprattutto senza spargimenti di sangue, fatto che convinse Ankara dell’efficacia dell’OLP .
Dopo tutti questi avvenimenti la Turchia accettò di concedere la presenza diplomatica palestinese a livello di chargè d’affaire, parificata quindi a quella Israeliana ed incassò il plauso dei vicini arabi.
I difficili anni ‘80
Nel periodo immediatamente successivo all’ennesimo colpo di stato militare in Turchia del settembre 1980, la situazione politica ed economica interna ritornò alla tranquillità; il percorso di avvicinamento ai paesi arabi incominciò ad avere tangibili ricadute economiche: la ripresa del sistema economico turco provocò un incremento della produzione dedicata all’export che, non trovando ampi sbocchi sul mercato europeo (la CEE si irrigidì a causa del golpe militare), ne trovarono invece negli Stati limitrofi. Ciò pose Ankara sin da subito in una situazione difficile: nel luglio del 1980 Israele dichiarò di voler spostare la propria capitale nella città di Gerusalemme; nello stesso mese una delegazione di quindici Stati musulmani guidati dal rappresentante in Turchia dell’OLP, incontrarono il Primo Ministro turco Suleyman, chiedendo la rottura delle relazioni diplomatiche con Israele . Suleyman non era dello stesso avviso, ma anche per accontentare la combattiva opposizione del Partito della Salvezza, decise di richiamare il chargè d’affaire da Tel Aviv per consultazioni nelle quali rivalutare gli accadimenti; in agosto venne chiuso il consolato turco a Gerusalemme. Nel dicembre, in pieno regime militare, si decise di ridurre la presenza diplomatica turca in Israele al livello di “secondo segretario”; tale scelta venne motivata dall’approccio israeliano “intransigente sul conflitto Mediorientale e sullo status di Gerusalemme” . Con questo gesto, forte ma non di rottura aperta con Israele, la Turchia riuscì a mantenersi nel suo delicato equilibrio di Stato musulmano interessato a trovare una soluzione alla questione palestinese, senza poter essere etichettato come anti-occidentale. La conferma di ciò avvenne nel 1982, quando durante il voto all’ONU sulla risoluzione che condannava l’annessione delle alture del Golan da parte di Israele e chiedeva alla Comunità Internazionale di prendere le misure più appropriate (ES 9/1), Ankara si astenne .
Nel 1984 si tenne a Casablanca il quarto incontro dell’Organizzazione della Conferenza Islamica, la Turchia vi partecipò scatenando l’inquietudine delle cancellerie occidentali; la delegazione turca era guidata infatti dal Presidente Evren ( era la prima volta che ad un incontro “islamico” la Turchia inviava la sua massima carica) che nel suo discorso chiamò gli Stati arabi ad unirsi: “attorno ad una singola, effettiva e realistica contro-strategia” da opporsi a quella israeliana nella regione . Sebbene le parole usate dal Presidente possano sembrare poco moderate, il punto di riferimento al quale stringersi venne esplicitato nel “Piano di Fez”, approvato dal summit arabo del 1982, nel quale si riconosce, sebbene implicitamente, lo Stato di Israele. L’appello era quindi moderato e la Turchia volle ribadire nel 1986 attraverso il suo Primo Ministro Ozal la necessità turca di mantenere i contatti con Israele come “finestra su futuri eventi” . L’apertura di Ozal fu forse la conseguenza del fatto che nel 1985 Israele volle far notare la propria benevolenza inviando una rinnovata missione diplomatica ad Ankara, ripristinata al grado di chargè d’affaire; l’anno dopo la Turchia restituì il favore, riportando le relazioni bilaterali a quelle pre 1980 . Il riavvicinamento ufficiale fra i due Stati, venne “celebrato” all’ONU nel settembre del 1987 quando i rispettivi Ministri degli Esteri si incontrarono durante un meeting dell’Assemblea Generale.
Ciò nonostante Ankara riuscì a non guastare i rapporti – mai facili – con l’OLP e nel 1988, infatti, il 15 novembre, la Turchia fu il primo ed unico membro dell’Alleanza Atlantica a riconoscere il “nuovo Stato Palestinese”, nato dall’incontro della dirigenza dell’OLP ad Algeri tra il 12 ed il 15 dello stesso novembre . Ankara vide di buon occhio quest’iniziativa palestinese perché vi si accettava la risoluzione ONU 242, che prevedeva il riconoscimento dell’esistenza di Israele, in linea con la posizione turca.
Se come abbiamo visto gli anni ’80 furono un momento, se non critico nemmeno disteso, nei rapporti bilaterali Turchia-Israele, il decennio successivo passerà alla storia come il periodo di maggior intesa fra i due Paesi in cui le divergenze passate apparirono come “spettri remoti”.
La nascita dell’asse Ankara-Tel Aviv
La posizione turca di “equidistanza” nelle sue relazioni fra mondo arabo ed occidentale, subisce un forte shock con la prima guerra del Golfo scoppiata nell’agosto del 1990, facendo pendere la bilancia turca, verso posizioni esplicitamente filo-americane . L’invasione del Kuwait da parte irachena, venne sfruttata dal Presidente Ozal per presentare la Turchia nella nuova veste di alleato strategico per gli Usa; tale scelta colse di sorpresa molti turchi, anche fra i meglio informati come il capo di Stato Maggiore Torumtay, che alla richiesta di dispiegare le truppe sul confine iracheno, rispose dando le dimissioni . La decisone turca non fu però un fulmine a ciel sereno, ma un’attenta valutazione strategica: i membri della NATO, soprattutto quelli europei, dimostrarono grande titubanza nello schierare unità aeree o di artiglieria sul suolo turco, facendo aumentare il sentimento di isolamento e di vulnerabilità di Ankara, al quale questa rispose proponendo a Washington di stringere una “nuova cooperazione strategica” mai decollata . Oltre a ciò, l’interesse turco per Baghdad risiedeva – e risiede tutt’ora – nella nutrita comunità curda, che l’Iraq ospita nella parte settentrionale del paese; questa avrebbe potuto organizzarsi in un’entità politica autonoma, e destabilizzare ancor più le provincie turche confinanti, dove da anni si stava svolgendo un sanguinoso braccio di ferro fra esercito turco e militanti del Pkk (Partito Lavoratori del Kurdistan) .
Ankara giocò un ruolo fondamentale nella strategia Usa verso l’Iraq; senza una sua effettiva collaborazione, la risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 661, che sanciva il totale embargo a Saddam Hussein sarebbe stata di scarsa efficacia . Non fu una posizione indolore però, la Turchia infatti troncò un discreto scambio di merci (valutabili attorno al miliardo di dollari per i beni/servizi ed altri 700 milioni di “scambi invisibili”) ma soprattutto, il cruciale oleodotto Kirkuk-Yurmurtalik rinunciando a petrolio e soprattutto alle royaltes che Ankara incassava da quello (c.ca 300 milioni di dollari) .
Oltre a ciò, la Turchia dopo mesi di dibattito parlamentare, accettò che dal 15 gennaio 1991 le proprie basi, in particolare quella dell’aeronautica presso Incirlik, potessero essere utilizzate dalla NATO per lanciare attacchi verso l’Iraq, cosa che avvenne già il giorno 18 . Durante le vere e proprie operazioni belliche, l’esercito turco non sconfinò ma si limitò a garantire la sicurezza del confine iracheno; scesa la calma sul campo di battaglia, emerse però il problema dei rifugiati, soprattutto curdi che vennero, in un primo momento, accolti nella penisola anatolica. Per Ankara questo fu il momento di maggior tensione con il Pkk, che godendo dell’instabilità irachena e del gran numero di armi ivi presenti, incominciò a bersagliare i soldati turchi; tra il 5 ed il 16 agosto 1992 la Turchia portò avanti un’operazione di rastrellamento in tutto il Nord Iraq, provocando decine di morti ed attirandosi critiche, soprattutto da parte europea.
Oltre che per il conflitto iracheno, nei primi anni ‘90 la diplomazia turca si fece notare per altre due scelte: nel dicembre del 1991, il giorno 16, la delegazione turca all’ONU si astenne dal votare la riproposizione della risoluzione del 1975 che chiedeva di inserire il Sionismo fra le ideologie razziste (A/RES/3379 e A/RES/46/86), mentre, cosa ben più importante, decise di promuovere le proprie relazioni bilaterali sia con Israele sia con l’OLP al massimo livello di “ambasciatore” il 19 dello stesso mese .
Quest’ultima scelta non venne presa casualmente, ma venne concepita dai turchi come una mossa tattica ribadire la propria posizione sul conflitto arabo-israeliano; sei settimane prima si era svolta la Conferenza di Madrid, dove le discussioni vertevano tutte sulle risoluzioni ONU 242 e 338, entrambe in linea con il pensiero di Ankara . Nonostante il trattamento turco, formalmente paritetico rispetto ad Israele, l’OLP scomparì quasi del tutto dall’agenda di Ankara; innanzitutto Arafat commise l’errore di appoggiare Saddam Hussein durante la guerra del Golfo, mentre cosa di maggior rilievo, la Turchia valutò come poco remunerativa la sua politica pro-araba. Il prezzo del petrolio non era più così proibitivo come nei primi anni ’80 e già nel 1992, le esportazioni turche fluivano per ben due terzi verso i Paesi OCSE, mentre solo un 20% era diretto verso Stati musulmani, inclusi quelli non arabi dell’Asia centrale ed orientale . Il Medio Oriente era quindi percepito dai turchi non più come un “mercato”, con il quale stringere rapporti di partnerariato, ma bensì come una delle regioni più instabili del globo. Israele era, da sempre, dello stesso avviso. Furono queste valutazioni sulla sicurezza dell’area che spinsero Ankara e Tel Aviv a stringere legami più solidi; nel giugno del 1992 si compì il primo piccolo passo, siglando un accordo bilaterale sulla cooperazione turistica . In novembre dell’anno seguente, il Ministro degli Esteri turco Cetin visitò Gerusalemme per proporre una collaborazione nelle neo Repubbliche caucasiche, e tornò in patria avendo concluso diversi accordi di scambio sia culturali che economici. Venne seguito nel 1994 dalla visita ufficiale del Primo Ministro Ciller, che nel suo viaggio a Tel Aviv lanciò la proposta di allacciare una “relazione strategica” e siglò due protocolli di collaborazione, uno di anti-terrorismo, l’altro di scambio di informazioni di intelligence .
Con la visita ufficiale del Presidente turco Demirel in Israele tra l’ 11 ed il 14 marzo le relazioni bilaterali conobbero un ulteriore salto in avanti; si firmarono altri quattro accordi su: cooperazione economica, zona di libero scambio (mai avviata), promozione e protezione degli investimenti reciproci e norme per prevenire una doppia imposizione fiscale nei rapporti commerciali . Sul versante strategico invece, si era già giunti ad una collaborazione militare, decisa il 23 febbraio del 1996, dove si prevedeva che gli eserciti dei due Paesi avrebbero svolto esercitazioni comuni, soprattutto per quanto riguarda l’aeronautica, e che quella Israeliana avrebbe avuto accesso ai cieli turchi per impratichirsi del volo in zone montagnose . Qualche mese più tardi, il 26 agosto, ci si accordò anche per lo scambio di tecnologia militare avanzata, fatto che permise alla Turchia di aver nuovamente accesso ad armamenti moderni dopo vent’anni di embargo Usa (dal 1975 Washington decise di usare tale strumento per fare pressioni riguardo la questione cipriota). La Turchia si lanciò in un programma di ammodernamento e riarmo delle proprie forze armate, prevedendo di spendere 31 miliardi di dollari nei primi cinque anni e di raggiungere la somma di 150 miliardi, nell’arco di mezzo secolo; Israele avrebbe contribuito sia fornendo direttamente gli armamenti, sia la tecnologia necessaria per poter avviare la produzione bellica direttamente in Turchia . In questa cornice, Israele ottenne tra il 1996 ed il 2001, commesse per 54 aerei da combattimento classe F-4 Phantom, di 48 F-5 (in collaborazione con un partner di Singapore), per la fornitura di 23 sistemi di droni e di 4 aerei radar; dal lato della coproduzione ci si accordò per centinaia di missili aria-terra Popeye I e II, un migliaio di carri armati di nuova generazione, di 145 elicotteri d’attacco e, dal 1998, lo sviluppo di un programma missilistico antibalistico simile al sistema Arrow con un raggio d’azione di 150 km .
Da parte israeliana l’avvicinamento strategico ad Ankara, fu la conseguenza di un cambio di strategia dall’unilateralismo al multilateralismo; le motivazioni sottostanti tale scelta possono essere individuate nella proliferazione regionale di missili a lungo raggio e di armi di distruzione di massa e dalla riflessione, conseguente alla guerra del Golfo quando vide il suo territorio minacciato dagli scud iracheni, di non possedere più un’autonoma capacità di tutela dei propri interessi . Inoltre grazie alla forza militare del nuovo alleato e della sua posizione geografica , Tel Aviv seppe di poter esercitare una forte deterrenza sui tre suoi acerrimi nemici: Iraq, Iran e Siria che, infatti, protestarono vivamente ed incominciarono a rafforzare o rinnovare i loro rapporti diplomatici . Ai malumori espressi dalla quasi totalità delle cancellerie mediorientali (eccezion fatta per la Giordania), le diplomazie turche ed israeliane risposero che i loro rapporti strategici non erano motivati da intenti aggressivi, e che questi non fossero diretti a minacciare alcuno Stato terzo . Sebbene il peso delle questioni militari fu sicuramente notevole nella relazione bilaterale Turchia-Israele, alcuni sottolineano che l’utilizzo della parola “alleanza” sia erroneo proponendo la definizione di “partnership strategica”; nella concezione tradizionale del termine infatti, si sottointendono qualità specifiche quali: la definizione del casus foederis ossia le cause che obbligano i contraenti ad un’assistenza militare reciproca, mancano del tutto i riferimenti per definire una difesa mutuale e non si accenna a coordinazioni militari formali .
L’intesa fra i due paesi, apparve in questa fase come: solida, stabile e duratura; erano le due maggiori forze economiche e militari della regione, entrambi condividevano la volontà di mantenere lo status quo in Medio Oriente, seguivano un approccio filo statunitense ed i legami commerciali e di difesa sottolineavano la volontà di protrarre questa relazione nel lungo periodo . Poi venne l’ 11 settembre, il mondo cambiò e così anche i rapporti fra Turchia ed Israele.
La fine di un’amicizia
Quando nel mondo occidentale scoppiò – e venne alimentato – il terrore per il “mondo islamico” dopo i tragici eventi che insanguinarono le strade degli Stati Uniti nel settembre 2001, anche nei Paesi musulmani si acutizzò la tendenza a guardare agli eventi globali come ad uno “scontro fra civiltà”.
Questo gettò benzina sul fuoco sulla percezione (mai ottima) che i musulmani avevano di Israele, già fortemente criticata, anche in Turchia, dallo scoppio della seconda intifada . Fino al 4 aprile del 2002, i rapporti fra Turchia ed Israele si mantennero distesi; sebbene nelle città turche avvenissero numerose manifestazioni per condannare l’uso della forza militare israeliana contro la popolazione palestinese, la diplomazia di Ankara tese a tenere separate le relazioni israelo-turche da quelle israelo-palestinesi . Quel giorno però, il Primo Ministro Turco Bulent Ecevit impressionato dal bombardamento della residenza di Arafat, durante una riunione del suo partito denunciò Israele per il “genocidio” che stava portando avanti nei riguardi dei palestinesi e gli Usa per la loro indifferenza; in meno di quarantott’ore questi ricevette la chiamata del Vice Presidente americano Dick Cheney e lettere di protesta da parte di nove influenti organizzazioni ebraiche . Il giorno seguente Ecevit provò a sminuire la portata delle sue parole, sostenendo che fossero state interpretata troppo eccessivamente e, che lui volesse esprimere il sentimento comune a molti nella regione; disse che la politica turca verso Israele non era cambiata e due settimane dopo lanciò una campagna per confermare la cooperazione fra i due Stati . A parte le proteste ufficiali, l’unico effetto immediato che tale dichiarazione ebbe nelle relazioni bilaterali, fu la cancellazione delle esercitazioni di marina congiunte.
Certamente gli Usa ebbero un certo peso nel distendere i rapporti fra Tel Aviv ed Ankara; impegnati nelle operazioni belliche della seconda guerra del Golfo, necessitavano dell’appoggio turco per far stazionare le proprie truppe in Turchia, di usarne le basi aeree e di utilizzarne la frontiera con l’Iraq come per aprire un secondo fronte. La proposta americana prevedeva la dislocazione di 62.000 soldati Usa in Turchia, la richiesta di invio di truppe turche in Nord Iraq, due miliardi di dollari in forma di “aiuto”, la redifinizione per 24 miliardi di dollari di debito turco e la promessa di mantenere l’Iraq unito (e quindi di non appoggiare le richieste curde di un Iraq federale) . Tutto ciò non bastò a convincere il governo di Ankara; ufficialmente si sostenne che fino a quando sarebbe mancata una legittimazione internazionale alla guerra, il parlamento non avrebbe potuto votare la partecipazione turca .
Intanto le relazioni turco-israeliane sembravano tornare alla normalità: nel luglio del 2003 il Presidente israeliano Moshe Katsav visitò Ankara, il ministro degli Esteri turco invitò ed incontrò il suo omologo israeliano ed in agosto si tennero le manovre di marina congiunte Turchia-Usa-Israele (Reliant Mermaid) al largo delle coste anatoliche . Passati pochi mesi, nel marzo del 2004, volarono nuovamente scintille: da una parte il Ministro degli Esteri turco Gul espresse la volontà di inviare un ambasciatore presso l’ANP, dall’altra Israele rispose che avrebbe fatto lo stesso nel “Kurdistan” nord iracheno, provocando la chiamata ad Ankara dell’ambasciatore turco in Israele per consultazioni, ed in seguito il suo repentino ritorno in sede . In settembre poi, il Primo Ministro turco Recep Erdogan, accolse presso il parlamento turco una delegazione palestinese guidata da Abbas Zaki, riaffermando la condanna agli attacchi israeliani sui civili palestinesi e promettendo una maggior assistenza turca . Lo stesso Erdogan rincarerà la dose, dopo che nella striscia di Gaza vennero assassinati i massimi esponenti di Hamas Ahmad Yassin e Abd al’Aziz al Rantisi, definendo l’accadimento come “terrorismo di Stato”; Ankara richiamò nuovamente ambasciatore e console per consultazioni, denunciando con vigore “a violenza delle azioni israeliane contro i palestinesi” . Nel gennaio del 2005 si tentò di ricucire lo strappo; il Ministro degli Esteri turco Gul fece visita ad Israele e Territori Occupati, seguito da un centinaio fra uomini d’affari e giornalisti . Poco più tardi fece lo stesso Erdogan, anch’egli con un largo seguito di affaristi, che dichiarò che la Turchia “ha buoni rapporti con Israele che non ci impediscono di esercitare delle sane critiche. La mia visita doveva servire a dare nuovo impeto a questa relazione” . Israele rispose conciliante accogliendo di voler riprendere l’amicizia con l’alleato, ricordando l’importanza dell’ingresso turco nella UE, passo che “favorirà la stabilità in Medio Oriente”, e sostenendo che le relazioni con la Turchia “possono servire da modello per i Paesi arabi moderati” . Grazie a questi incontri si decise di ampliare lo scambio commerciale fra i due Paesi nei campi delle infrastrutture energetiche, dell’acqua e delle comunicazioni e di sviluppare una “Qualified Industrial Zone” congiunta, progetto nato nel 1997, ma rimasto sino a quel momento in un cassetto .
Anche quest’ultimo tentativo di ripristinare rapporti sereni con Tel Aviv ebbe breve durata; nel febbraio del 2006 il partito dell’AKP invitò Hamas ad inviare delegati in Turchia riconoscendolo prima di tutto come partito politico (a mesi si sarebbero svolte le elezioni dell’Autorità Palestinese), provocando vive proteste in Israele . Da parte israeliana sembrò che non fosse più possibile fidarsi totalmente di Ankara, si cercò di non pubblicizzare più di tanto lo strappo, se non nell’immediato, e continuare la relazione badando più agli affari che alla politica; quest’atteggiamento divenne chiaro l’anno seguente, quando Israele nella notte tra il 5 ed il 6 settembre compì un raid aereo contro posizioni siriane nei pressi di Deir ez Zor . Il fatto passò del tutto inosservato, sia dai Paesi arabi sia da quelli occidentali; Ankara non venne allertata, sebbene i caccia israeliani ne avessero sorvolato territorio ed acque territoriali, per giungere a destinazione, e protestò fortemente per vie diplomatiche . Il malumore turco rientrerà solo due mesi più tardi, quando Olmert a Londra e Peres ad Ankara pronuncieranno formalmente le loro scuse per l’accaduto .
Fu però un’altra azione bellica israeliana, a rompere definitivamente la fiducia turca nei suoi riguardi, ossia l’ “Operation Cast Lead” del 27 dicembre 2008. Tra il 27 dicembre ed il 2 gennaio caccia israeliani bombardarono la striscia di Gaza, colpendo obiettivi militari e civili, sostenendo che questa fosse una risposta al lancio di alcuni missili da parte di Hamas sul suo territorio . Il tre gennaio incominciarono le operazioni di terra che coinvolsero la città di Gaza, provocando tra i 1100 ed i 1400 morti civili; il 18 gennaio Israele annunciò unilateralmente il cessate il fuoco e smobilitò definitivamente il 21 dello stesso mese . L’operazione fu un vero e proprio massacro, aggravato dall’uso di armi quali il fosforo bianco e bombe del tipo “Dense Inert Metal Explosive” su civili inermi . Nella confusione fra le cancellerie arabe, il premier turco Erdogan si accreditò come mediatore; d’altronde la Turchia era rispettata fra gli arabi, aveva solidi legami con Israele, un’importante partnership con gli Usa e da mesi stava facendo pressioni su Israele perché alleviasse l’embargo a Gaza . La posizione di Erdogan passò velocemente da quella di mediatore, a quella di parte in causa condannando vivamente l’accaduto ed ipotizzando di riconsiderare i legami economici e strategici con Isreale .
La rottura divenne plateale al vertice del World Economic Forum di Davos del 23-27 gennaio 2009, quando Erdogan condannò con grande foga l’operazione Israeliana, chiamandola “crimine contro l’umanità” ed arrivando allo scontro verbale con il Presidente Shimon Peres . La vicenda ebbe strascichi ulteriori nel 2010, quando, in pieno tono di sfida, Ankara organizzò, collaborando con la ong Foundation of Humanitarian Relief, una spedizione umanitaria navale chiamata “Freedom Flottilla” per rompere l’embargo sulla striscia di Gaza e rifornire la popolazione di generi di prima necessità . Per Tel Aviv quello era semplicemente un atto di aggressione: dichiarò che la flottiglia era composta da fiancheggiatori di terroristi, che a bordo delle navi probabilmente vi erano armi dirette ad Hamas e che quindi la spedizione navale non avrebbe avuto il permesso di attraccare nella Striscia, se non dopo un’ispezione israeliana presso il porto di Ashdod che gli attivisti rifiutarono . Il 31 maggio, in piene acque internazionali, un commando israeliano fece entrò in azione, uccidendo nove civili di nazionalità turca e ferendone altre decine . La reazione di Ankara fu furiosa, Erdogan interrompendo il proprio viaggio di Stato in America Latina rientrò in patria, dove davanti al parlamento minacciò che “Israele pagherà a caro prezzo l’effusione di sangue turco”; il Ministro degli Esteri Davutoglu volò immediatamente a New York per intervenire davanti alla riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza, condannando vivamente Israele (il Consiglio si limitò però a deplorare il comportamento israeliano) . Per un attimo si temette una risposta militare turca.
Intanto il Segretario Generale dell’ONU promise di dare il via ad una indagine conoscitiva sull’incidente in modo “pronto, imparziale, credibile e trasparente, in conformità con gli standard internazionali” . La Turchia insistette per ottenere scuse formali e l’avvio di una commissione di indagine internazionale. Il 23 luglio 2010 il “United Nations Human Rights Council” diede il via alle investigazioni internazionali sull’accaduto; le conclusioni furono che il commando israeliano uccise a sangue freddo sei civili a bordo della “Mavi Marmara” e dichiarò che non vi fossero prove di colpi d’arma da fuoco da parte degli assaliti . Nel rapporto, si raccomandò che Israele pagasse una somma risarcitoria e che l’embargo totale sulla striscia di Gaza fosse “totalmente intollerabile ed inaccettabile per il XXI secolo” .
Ad oggi le relazioni bilaterali fra Turchia ed Israele sembrano ancora soffrire a causa di questo tragico evento; volendo sbilanciarci, possiamo prevedere che nel prossimo futuro i rapporti si manterranno solidi sul piano economico, ma che un’intesa strategica simile a quella fiorita nei tardi anni ’90 è altamente improbabile.
La Turchia nel XXI secolo
Per comprendere il presente, e per azzardare qualche ipotesi sulle relazioni internazionali turche future, è utile partire dal poderoso volume pubblicato nel 2001 dal professore Ahmet Davutoglu, consigliere per la politica estera di Erdogan e, dal 2009, a capo della diplomazia turca, noto come “Profondità strategica” .
Come la Turchia vede il mondo
Il testo, seppur presentato come lavoro accademico, spicca per il suo afflato utopico, idealistico e di grandeur, che l’autore continua a rivendicare, sostenendo che “Il mondo si aspetta grandi cose dalla Turchia” . Se nel 2001, con un’economia turca ancora traballante, questo spirito poteva essere bollato come nazionalismo sognatore, oggi, con una popolazione superiore a quella tedesca, un esercito di prim’ordine, e con le proiezioni che prevedono per la Turchia di diventare la terza economia europea entro il 2050 (nona a livello mondiale), possiamo assolutamente essere d’accordo con Davutoglu: il mondo si aspetta davvero grandi cose dalla Turchia .
Il pensiero del capo della diplomazia turca si sviluppa secondo le seguenti linee fondamentali .
Innanzitutto, l’autore parte da una riflessione sulla fine del bipolarismo, inteso come situazione costrittiva per Ankara, che per troppo tempo ha ricoperto il ruolo marginale e riduttivo di “braccio armato” degli Usa nel loro confronto con l’ex Urss; propone, quindi, di riflettere sulle nuove opportunità apertesi con il vuoto di potenza nell’area che comprende dal Mediterraneo al Turkestan orientale, dal Danubio al Nilo e, soprattutto, nel Medio Oriente a proposito del quale si afferma: “questa regione ci appartiene, è casa nostra” . Per chi volesse ancora domandarsi se l’asse geostrategico turco penda ad Est o ad Ovest la risposta arriva categorica: “l’asse è Ankara” .
In secondo luogo, vengono individuate otto aree di influenza per la Turchia (recuperando la vocazione ottomana, declinata in salsa panturchista e senza dimenticare il fattore Islam), precisamente: Balcani, Mar Nero, Caucaso, Caspio, Asia centrale, Golfo Persico, Medioriente e Mediterraneo. Queste, quindi, le direttive della nuova politica estera turca, che si vuole centrale e di conseguenza non più periferica ma, soprattutto, autonoma.
Il terzo punto che viene sottolineato da Davutoglu è l’approccio “zero problemi con i vicini”; l’obbiettivo di Ankara è, cioè, quello di creare una regione non costellata da barriere, ma unita dalla cultura e dall’economia; si vuole stabilire un ordine pacifico, che strizza l’occhio ad un passato ottomano, inteso come multietnico, multireligioso e tollerante, insomma una Pax Ottomana.
Un ulteriore fondamentale pilastro viene dall’autore individuato nell’economia: grazie alla recente impennata del sistema produttivo turco, e soprattutto alla fortunata proiezione geo-energetica, la Turchia vuole andare oltre a vecchie inimicizie che, in nome degli interessi comuni, si possono superare anche se profondamente radicate (Iran e Russia docent).
Infine si analizzano i rapporti con l’Occidente. In proposito, Stati Uniti ed Europa sono considerati come ottimi partner, sia strategici sia commerciali, ma non più come l’alfa e l’omega dell’estero turco; ora, infatti, Ankara vuole davvero giocare da “ponte” fra un Occidente certamente prospero, ma in declino, ed un Oriente galoppante, ma ancora enigmatico dal punto di vista degli equilibri di potenza mondiali (per questo motivo Ankara sembrerebbe puntare molto nel creare un Medio Oriente a guida turca, così da avere qualche certezza nel disordine attuale).
Come il mondo vede la Turchia
Il grande interesse che Ankara ha attirato su di sé – basti pensare che da J. W. Bush in avanti la Turchia è stata al centro della diplomazia a stelle e strisce – ha prodotto sentimenti fortemente contrastanti riguardo il ruolo e le intenzioni della patria di Ataturk . Da una parte, cassandre soprattutto statunitensi ed israeliane, hanno evocato il fantasma di un neo-ottomanismo inteso come volontà di sradicamento delle radici cristiane dell’Europa , di politica estera spregiudicata (con riferimento ai rapporti con Russia e soprattutto Iran ) e di islamismo militante atto a scatenare la umma in un jihad globale . Dall’altra parte, da quando Ankara, sul finire degli anni ’90, ha deciso di estendere la propria influenza in Medioriente, dalla cooperazione con Israele (’97), alla partecipazione alle azioni belliche in Nord Iraq (’07) ai tentativi di mediare fra Damasco e Gerusalemme (’07), ai già citati rapporti con l’Iran (’07), ma, soprattutto, da quando ha deciso di non ignorare più la questione palestinese nei suoi rapporti con Israele (’08), la popolarità della Turchia nell’area è schizzata alle stelle. Peraltro, le premesse per una leadership regionale ci sono tutte: prima fra tutte, un soft-power basato, oltre che su di un’economia galoppante (nel 2010 il PIL ha conosciuto un +11%), anche su legami cultural/religiosi, poi un approccio pragmatico, soprattutto nelle questioni commerciali, ed una politica estera riassunta nello slogan “Zero problemi con i vicini”, non ultimo un hard-power rappresentato dal suo esercito, formidabile macchina da guerra (secondo solo a quello israeliano), che tuttavia non ha mai utilizzato per aggredire alcuno Stato (eccezion fatta per il suo impiego in chiave anti Pkk nelle province settentrionali dell’Iraq, in entrambe le guerre del Golfo).
Oltre ad aver rilanciato l’immagine della Turchia nell’estero vicino, i contatti con Ankara sono visti con grande benevolenza anche in altre parti del globo: nei Balcani, ad esempio, non ha mai perso i contatti con le ex provincie ottomane con le quali intrattiene ottimi rapporti, nessuna esclusa (Ankara sarà fra le prime a riconoscere l’esistenza del Kosovo, senza attirare nessuna critica!); anche in America Latina ha ottimi rapporti con Brasile, Barbados e Cile (solo l’Argentina mantiene le distanze a causa della nutrita diaspora armena); in Asia Centrale si è affermata come player imprescindibile nel “grande gioco energetico”, mentre nell’Asia Orientale è accolta calorosamente a New Delhi come ad Islamabad, ma anche in Indonesia, Giappone, Malesia, Bangladesh e Vietnam .
Ad onor del vero, un piccolo incidente di percorso si è consumato nel 2009 nei rapporti con la Cina, quando sono scoppiate le contestazioni iugure (etnia di origine turca), duramente represse da Pechino causando le dimissioni di un componente turco dal Gruppo interparlamentare di amicizia Turchia-Cina . Tale vicenda, paradossalmente, sembrerebbe aver rilanciato i rapporti bilaterali; se nel 2008 si discuteva solo di commercio, nel 2010 si è arrivati, infatti, a siglare otto accordi di cooperazione su commercio, cultura, scienza, assistenza tecnica, navigazione, controterrorismo e polo industriale turco nello Xinjiang; inoltre, si è deciso per trasformare la relazione in “alleanza strategica” .
La Turchia di domani
Prevedere il futuro è una delle ambizioni degli studiosi di Relazioni Internazionali; attraverso l’analisi delle dinamiche storiche, politiche, sociali ed economiche presenti e passate, questa disciplina cerca, infatti, di gettar luce sui possibili scenari futuri.
Purtroppo, però, è anche il terreno delle congetture, che vengono disilluse il più delle volte; l’uomo, infatti, è un essere irrazionale e, proprio per questo, un approccio di stampo scientifico spesso non è in grado di cogliere tutti gli aspetti, o rischia di portare a conclusioni errate. In questa sezione dedicata agli scenari futuri ci si atterrà, quindi, alla maggiore prudenza possibile ed alla brevità.
Per cominciare, riprendiamo alcune tendenze ricorrenti nelle relazione della Turchia con il mondo: pragmatismo unito ad una ideologia solida (variabile nel tempo, ma sempre in grado di dare slancio ai progetti di Ankara), relazioni con gli altri basate più sul mutuo vantaggio che sull’imposizione, modernismo declinato di volta in volta sullo zeitgeist del momento e, soprattutto, un sentimento di grandezza espresso anche nell’assecondare le scelte delle potenze dominanti, così da poter sfruttare le migliori occasioni che la contingenza storica può offrire. La Turchia appare, quindi, in grado, se non di prevedere il futuro, di adattarsi bene e velocemente al presente.
Il momento odierno rappresenta sicuramente una sfida per Ankara, che ha dimostrato di aver compreso il passaggio da un mondo prima bipolare, per un attimo fuggente unipolare e, oggi, multipolare. Ciò è evidente soprattutto se si guarda al cessato atteggiamento di bandowing verso gli Usa, percepiti non più come l’ombelico del mondo. La mossa contingente è stata – come si è visto prima – quella di cercare di riallacciare i rapporti nella regione mediorientale, così da potersi giovare nel medio periodo di una zona di influenza stabile che le permetta poi di riflettere a più ampio raggio. L’opzione europea non viene mai abbandonata, ma se, fino a qualche anno fa era il principale obbiettivo della politica estera turca, oggi non rimane che un’opzione (importante) fra le molte .
Se il Washington Consensus sembra aver sorpassato l’apice, e quindi iniziato un percorso di declino, non è ancora possibile parlare di un Beijing Consensus definito o definibile; sicuramente la Cina è emersa come seconda economia globale ed attore internazionale con il quale tutti (Usa compresi) devono fare i conti, ma sia per ragioni culturali a lei interne (rifiuto di un egemonismo imperialista ) e sia per l’incertezza odierna, è difficile coglierne la sua collocazione futura. Ankara, da parte sua, ha ben chiaro che l’Asia ed i cosiddetti Bric (Brasile, Russia, India e Cina) saranno il motore che muoverà gli eventi globali futuri, ed è per questo che ha approfondito i rapporti bilaterali con ciascuno di questi; resta da comprendere, a questo punto, se e quale Stato incarnerà “l’uomo forte”, atavico archetipo che ha da sempre affascinato la mentalità turca e che, nel caso dovesse emergere, troverà, ad avviso di chi scrive, nella Turchia un fedele alleato. In caso contrario, tuttavia, rimane aperta la possibilità di fare da ponte fra mondo occidentale ed orientale, provando a diffondere un sentimento di comprensione reciproca, quasi scomparso nell’ultimo decennio, in quello che da più parti è stato letto come uno scontro fra civiltà.
Archiviato in Turchia
Similitudini fra le crisi economiche del 1929-2008, versante finanziario
Versante finanziario
Il motivo che mi ha spinto ad una comparazione fra la Grande Depressione del 1929 e l’attuale crisi economica, risiede nel fatto che numerose caratteristiche le accomunano, nonostante le grandi trasformazioni che il mondo ha conosciuto negli ultimi ottant’anni.
In una prima analisi si possono elencare alcune evidenti similitudini riscontrabili nel settore finanziario; in primis, è riscontrabile lo stesso clima euforico, che si respirava negli ambienti finanziari nei periodi appena antecedenti le crisi: prima del crollo del 29’ la finanza Usa aveva conosciuto un forte boom, nell’immobiliare conclusosi nel 1925 e nella impressionante crescita dell’indice azionario di Wall Street, che nel tre settembre 1929, toccò il picco del Dow Jones di 381,1725.
Per quanto riguarda la situazione odierna invece, l’esuberanza del settore finanziario americano, ma anche mondiale, è evidente dal 1994, con una caduta nel 2001, ma sarà nel 2007, il nove settembre, quando il Dow Jones raggiungerà l’indice massimo di 14164,53, che si toccherà con mano l’apice americano.
Anche in questa crisi, la bolla immobiliare, finanziata e rifinanziata ampiamente, ha avuto conseguenze dirompenti: infatti, proprio come nel 1929, le autorità monetarie furono totalmente neutrali nei confronti delle valutazioni degli asset26, sia immobiliari che azionari, ponendo la loro attenzione esclusivamente all’inflazione dei prezzi al consumo.
Proprio come negli anni 20’ quindi abbiamo elevatissimi rialzi nei prezzi degli asset, accompagnati da un’inflazione contenuta, che ha comportato un fortissimo indebitamento delle famiglie statunitensi sia per l’acquisto di immobili, che sembravano essere alla portata di tutti, poiché con prezzi in continua crescita chiunque aveva la tentazione di indebitarsi scommettendo sui ricavi futuri frutto della vendita dell’immobile a prezzo maggiorato, ma anche per beni non durevoli quali i servizi essenziali come istruzione e sanità.
Altra importante similitudine, è una prorompente innovatività del settore finanziario, riscontrabile in entrambi i periodi; negli anni Venti furono inventati gli investment trusts e si conobbero grandi flussi speculativi, grazie al finanziamento degli acquisti in borsa con grandi capitali a margini temporali molto contenuti.
Gli intermediari finanziari erano molto aggressivi sul mercato, infatti, offrivano finanziamenti a basso costo anche per impieghi ad alto rischio, questo perché ad avviso di Rosselli27: “L’esperienza americana della banca mista, era stata, specialmente negli anni Venti, quella di un ordinamento bancario despecializzato quanto a durata del credito, a intermediazione in titoli di rendita e di partecipazione, a interessenza, in imprese non bancarie: le grandi banche costituivano veri e propri grandi magazzini della finanza”.
Stessa estensione del credito ed assunzione di rischi non gestibili, è riscontrabile nella finanza di inizio millennio, con operatori finanziari spinti alla competitività da un quadro di progressiva deregolamentazione, oltre all’esistenza di comparti operanti in assenza di controlli efficaci e di un enorme indebitamento del settore famiglie, come illustratoci da White28, nella sua analisi del debito delle famiglie americane fra il 1980 ed il 2005.
In questo studio è presentata una situazione dove il rapporto fra credito revolving e la mediana del reddito passò dal 3,2% al 13% mentre il debito ipotecario dal 57% al 156%, con la conseguenza di un annullamento della propensione al risparmio, e quindi l’imposizione al tesoro americano di una politica del tasso d’interesse il più basso possibile29, poiché ad ogni aumento dello stesso il reddito disponibile si sarebbe fortemente ridotto.
A ciò si aggiunga inoltre, il dramma delle sempre più frequenti bancarotte dei singoli, che negli Usa è passata dai 288000 casi del 1980, ai due milioni del 2005, per scendere ai 850912 fallimenti personali nel 200730.
Ulteriore somiglianza finanziaria fra il 1929 ed il 2008 è, sia il forte calo degli indici di borsa statunitense, -89,19% l’otto luglio del 1932, -42,28% il 27 agosto 2008, sia la loro grande volatilità, +14,87% il sei settembre 1931, +12,34% il 30 settembre del 1929, mentre il tredici ed il ventotto settembre 2008, vedono registrare impennate storiche, nel primo di +11,08% ossia il quinto rialzo maggiore nella storia borsistica americana, nel secondo del +10,88%, il sesto maggior rialzo.
Un ulteriore parallelismo storico-finanziario, potrebbe venire osservando il caso dell’Inghilterra degli anni Venti e degli Usa nel 2008, dove entrambi i paesi presentano un fortissimo disavanzo con l’estero.
La Gran Bretagna soprattutto con gli Usa, grazie a politiche deflazionistiche nel tentativo di mantenere un’egemonia finanziaria secolare31.
Gli Usa seguendo le orme britanniche, con il loro “impero a credito”32, dove, inserendosi nel solco del pensiero dell’ex presidente Reagan, citato da Dick Cheney: “Reagan ha provato che i deficit non contano”33, l’amministrazione Bush si è totalmente disinteressata dell’enorme debito pubblico americano (2676 miliardi di dollari a luglio 2008 per il debito estero, 400 miliardi di dollari di debito pubblico), soprattutto del debito estero (vd. Tabella seguente), a mio modesto avviso, per scacciare i segni di una recessione incombente già nei primi anni del millennio, dove l’economia americana era stata colpita dalla bolla speculativa di Internet passata alla storia con il nome di dot.com, ma anche per mantenere l’egemonia mondiale sui settori sia economici-finanziari sia in quelli militari.
La crescita economica infatti è stata alimentata dall’afflusso di risorse esterne come merci, capitali ed energia, a sostegno della domanda interna34, così da raggiungere il triplice scopo di avvantaggiare i consumatori esterni, limitare la pressione fiscale ed accollare ai creditori esteri una quota decisiva della spesa pubblica, con particolare riferimento ai bilanci del Pentagono.
L’interdipendenza fra Stati Uniti e Cina, con un mercato commerciale di oltre 300 miliardi di dollari nel quale i cinesi sono produttori di prima ed ultima istanza e gli americani i grandi consumatori, ha generato riserve per lo stato cinese di 1800 miliardi di dollari di cui 500 investiti in titoli del tesoro americano, diventa lampante con la nazionalizzazione, da parte dell’amministrazione ultraliberista Bush, di giganti del mutuo ipotecario come Fannie Mae e Freddie Mac, la cui gran parte dei titoli era in mano straniera, specie cinese. Bush arrivò ad assicurare telefonicamente Hu Jintao, così come i suoi diplomatici lo imitarono in tutto il mondo, e come ci fa notare l’ex segretario del Tesoro Usa Lawrence Summers35: “Le superpotenze normalmente non chiedono ai propri diplomatici di rassicurare altre nazioni su questioni di credibilità finanziaria”.
Principali detentori di titoli del debito estero Usa in miliardi di dollari, a luglio 2008.
( fonte: Us Department of Treausury / Fedral Reserve Board)
Giappone 593,4
Cina 518,7
Regno Unito 290,8
Paesi esportatori di petrolio* 173,9
Brasile 148,4
Centri bancari Caraibici** 133,5
Lussemburgo 75,8
Russia 74,1
Hong Kong 60,06
Svizzera 45,1
Taiwan 42,3
Norvegia 41,8
Germania 41,1
Messico 36
Corea del Sud 35,3
Turchia 32,4
Tailandia 31,8
Singapore 31,4
Canada 26,6
*Ecuador, Venezuela, Indonesia, Bahrein, Iran, Iraq, Kuwait, Oman Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Algeria, Gabon, Libia, Nigeria.
**Bahamas, Bermuda, Isole Cayman, Antille olandesi, Panamà
Archiviato in Economia
La Libia non rispetta il cessate il fuoco: l’Onu inizia le operazioni
La comunità internazionale potrebbe lanciare un attacco militare alla Libia proprio “nelle ore” seguenti il summit in programma oggi a Parigi. Lo ha dichiarato l’Ambasciatore francese all’Onu, Gérard Araud, in un’intervista alla Bbc. “Avremo un vertice a Parigi con tutti i principali protagonisti delle operazioni e delle iniziative diplomatiche. Dunque ritengo che sarà il momento buono per inviare un ultimo messaggio – ha detto l’Ambasciatore – penso che dopo il vertice, nelle ore che seguiranno, lanceremo l’intervento militare”.
“Il colonnello Gheddafi ha disprezzato i nostri avvertimenti. I popoli arabi hanno scelto di liberarsi dalla schiavitù. Queste rivoluzioni hanno aperto grandi speranze nei cuori di chi condividono la democrazia. Questi popoli arabi hanno bisogno del nostro aiuto e del nostro appoggio. E’ nostro dovere. Oggi noi interveniamo in Libia su mandato dell’ONU.” Sarkozy a termine del vertice di Parigi.
Sono stati avvistati alcuni aerei francesi da ricognizione sulla Libia.
AL JAZIRA, FORZE GHEDDAFI ENTRATE A BENGASI – Le forze di Gheddafi sono entrate alla periferia ovest di Bengasi, dove si sta combattento intensamente, secondo quanto afferma l’emittente Al Jazira, citando il suo inviato.
Un aereo è stato colpito e abbattuto su Bengasi: lo afferma l’inviato di Al Jazira International Tony Birtley, in collegamento in diretta dalla città in mano ai ribelli, dove si sta combattendo alla periferia occidentale. L’aereo, che era passato su Bengasi diverse volte, è stato visto sorvolare un’ultima volta con il reattore destro in fiamme e poi schiantarsi al suolo in una palla di fuoco. Una colonna di fumo nero si alza dal punto dello schianto. Non è ancora chiaro come l’aereo sia stato abbattuto né se lo schianto a terra abbia provocato vittime.
Al Jazira riferisce che l’esercito di Gheddafi attacca Bengasi dalla costa e da sud. La tv panaraba ha anche mostrato le immagini dell’aereo delle forze governative abbattuto nel cielo della città. L’aeroplano, probabilmente un Mig-23, prende fuoco in volo e precipita a terra, provocando una nuvola di fumo. Si vede chiaramente anche il pilota che si lancia all’esterno prima dell’impatto, a poche decine di metri da terra.
Il centro di Bengasi è bersaglio di un intenso bombardamento di artiglieria, dice l’emittente Al Jazira, che cita un suo inviato. Granate d’artiglieria, dice l’emittente, sono esplosi anche nella centrale Gamal Abdel Nasser Street.
GOVERNO, ESERCITO ATTACCATO DA RIBELLI A BENGASI – Il governo libico ha detto che le sue forze armate sono sotto attacco a ovest di Bengasi e hanno risposto per autodifesa. Lo riferisce Al Jazira. “Le bande di Al Qaida hanno attaccato le unità delle forze armate libiche ferme a ovest di Bengasi”, si legge in una dichiarazione riportata dall’agenzia ufficiale Jana. La dichiarazione accusa i ribelli di usare “un elicottero e un aereo da combattimento per bombardare le forze armate libiche, in flagrante violazione della no-fly zone imposta dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite”
Fonti: http://www3.lastampa.it/esteri/sezioni/articolo/lstp/394028/, http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2011/02/16/visualizza_new.html_1587570705.html
Archiviato in Libia, Medio Oriente
Onu approva risoluzione 1973, Gheddafi è nel mirino
The Security Council,
Recalling its resolution 1970 (2011) of 26 February 2011,
Deploring the failure of the Libyan authorities to comply with resolution 1970 (2011),
Expressing grave concern at the deteriorating situation, the escalation of violence, and the heavy civilian casualties,
Reiterating the responsibility of the Libyan authorities to protect the Libyan population and reaffirming that parties to armed conflicts bear the primary responsibility to take all feasible steps to ensure the protection of civilians,
Condemning the gross and systematic violation of human rights, including arbitrary detentions, enforced disappearances, torture and summary executions,
Further condemning acts of violence and intimidation committed by the Libyan authorities against journalists, media professionals and associated personnel and urging these authorities to comply with their obligations under international humanitarian law as outlined in resolution 1738 (2006),
Considering that the widespread and systematic attacks currently taking place in the Libyan Arab Jamahiriya against the civilian population may amount to crimes against humanity,
Recalling paragraph 26 of resolution 1970 (2011) in which the Council expressed its readiness to consider taking additional appropriate measures, as necessary, to facilitate and support the return of humanitarian agencies and make available humanitarian and related assistance in the Libyan Arab Jamahiriya,
Expressing its determination to ensure the protection of civilians and civilian populated areas and the rapid and unimpeded passage of humanitarian assistance and the safety of humanitarian personnel,
Recalling the condemnation by the League of Arab States, the African Union, and the Secretary General of the Organization of the Islamic Conference of the serious violations of human rights and international humanitarian law that have been and are being committed in the Libyan Arab Jamahiriya,
Taking note of the final communiqué of the Organisation of the Islamic Conference of 8 March 2011, and the communiqué of the Peace and Security Council of the African Union of 10 March 2011 which established an ad hoc High Level Committee on Libya,
Taking note also of the decision of the Council of the League of Arab States of 12 March 2011 to call for the imposition of a no-fly zone on Libyan military aviation, and to establish safe areas in places exposed to shelling as a precautionary measure that allows the protection of the Libyan people and foreign nationals residing in the Libyan Arab Jamahiriya,
Taking note further of the Secretary-General’s call on 16 March 2011 for an immediate cease-fire,
Recalling its decision to refer the situation in the Libyan Arab Jamahiriya since 15 February 2011 to the Prosecutor of the International Criminal Court, and stressing that those responsible for or complicit in attacks targeting the civilian population, including aerial and naval attacks, must be held to account,
Reiterating its concern at the plight of refugees and foreign workers forced to flee the violence in the Libyan Arab Jamahiriya, welcoming the response of neighbouring States, in particular Tunisia and Egypt, to address the needs of those refugees and foreign workers, and calling on the international community to support those efforts,
Deploring the continuing use of mercenaries by the Libyan authorities,
Considering that the establishment of a ban on all flights in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya constitutes an important element for the protection of civilians as well as the safety of the delivery of humanitarian assistance and a decisive step for the cessation of hostilities in Libya,
Expressing concern also for the safety of foreign nationals and their rights in the Libyan Arab Jamahiriya,
Welcoming the appointment by the Secretary General of his Special Envoy to Libya, Mr Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib and supporting his efforts to find a sustainable and peaceful solution to the crisis in the Libyan Arab Jamahiriya,
Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of the Libyan Arab Jamahiriya,
Determining that the situation in the Libyan Arab Jamahiriya continues to constitute a threat to international peace and security,
Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,
1. Demands the immediate establishment of a cease-fire and a complete end to violence and all attacks against, and abuses of, civilians;
2. Stresses the need to intensify efforts to find a solution to the crisis which responds to the legitimate demands of the Libyan people and notes the decisions of the Secretary-General to send his Special Envoy to Libya and of the Peace and Security Council of the African Union to send its ad hoc High Level Committee to Libya with the aim of facilitating dialogue to lead to the political reforms necessary to find a peaceful and sustainable solution;
3. Demands that the Libyan authorities comply with their obligations under international law, including international humanitarian law, human rights and refugee law and take all measures to protect civilians and meet their basic needs, and to ensure the rapid and unimpeded passage of humanitarian assistance;
Protection of civilians
4. Authorizes Member States that have notified the Secretary-General, acting nationally or through regional organizations or arrangements, and acting in cooperation with the Secretary-General, to take all necessary measures, notwithstanding paragraph 9 of resolution 1970 (2011), to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya, including Benghazi, while excluding a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory, and requests the Member States concerned to inform the Secretary-General immediately of the measures they take pursuant to the authorization conferred by this paragraph which shall be immediately reported to the Security Council;
5. Recognizes the important role of the League of Arab States in matters relating to the maintenance of international peace and security in the region, and bearing in mind Chapter VIII of the Charter of the United Nations, requests the Member States of the League of Arab States to cooperate with other Member States in the implementation of paragraph 4;
No fly zone
6. Decides to establish a ban on all flights in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya in order to help protect civilians;
7. Decides further that the ban imposed by paragraph 6 shall not apply to flights whose sole purpose is humanitarian, such as delivering or facilitating the delivery of assistance, including medical supplies, food, humanitarian workers and related assistance, or evacuating foreign nationals from the Libyan Arab Jamahiriya, nor shall it apply to flights authorised by paragraphs 4 or 8, nor other flights which are deemed necessary by States acting under the authorisation conferred in paragraph 8 to be for the benefit of the Libyan people, and that these flights shall be coordinated with any mechanism established under paragraph 8;
8. Authorizes Member States that have notified the Secretary-General and the Secretary-General of the League of Arab States, acting nationally or through regional organizations or arrangements, to take all necessary measures to enforce compliance with the ban on flights imposed by paragraph 6 above, as necessary, and requests the States concerned in cooperation with the League of Arab States to coordinate closely with the Secretary General on the measures they are taking to implement this ban, including by establishing an appropriate mechanism for implementing the provisions of paragraphs 6 and 7 above,
9. Calls upon all Member States, acting nationally or through regional organizations or arrangements, to provide assistance, including any necessary over-flight approvals, for the purposes of implementing paragraphs 4, 6, 7 and 8 above;
10. Requests the Member States concerned to coordinate closely with each other and the Secretary-General on the measures they are taking to implement paragraphs 4, 6, 7 and 8 above, including practical measures for the monitoring and approval of authorised humanitarian or evacuation flights;
11. Decides that the Member States concerned shall inform the Secretary-General and the Secretary-General of the League of Arab States immediately of measures taken in exercise of the authority conferred by paragraph 8 above, including to supply a concept of operations;
12. Requests the Secretary-General to inform the Council immediately of any actions taken by the Member States concerned in exercise of the authority conferred by paragraph 8 above and to report to the Council within 7 days and every month thereafter on the implementation of this resolution, including information on any violations of the flight ban imposed by paragraph 6 above;
Enforcement of the arms embargo
13. Decides that paragraph 11 of resolution 1970 (2011) shall be replaced by the following paragraph : “Calls upon all Member States, in particular States of the region, acting nationally or through regional organisations or arrangements, in order to ensure strict implementation of the arms embargo established by paragraphs 9 and 10 of resolution 1970 (2011), to inspect in their territory, including seaports and airports, and on the high seas, vessels and aircraft bound to or from the Libyan Arab Jamahiriya, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to believe that the cargo contains items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by paragraphs 9 or 10 of resolution 1970 (2011) as modified by this resolution, including the provision of armed mercenary personnel, calls upon all flag States of such vessels and aircraft to cooperate with such inspections and authorises Member States to use all measures commensurate to the specific circumstances to carry out such inspections”;
14. Requests Member States which are taking action under paragraph 13 above on the high seas to coordinate closely with each other and the Secretary-General and further requests the States concerned to inform the Secretary-General and the Committee established pursuant to paragraph 24 of resolution 1970 (2011) (“the Committee”) immediately of measures taken in the exercise of the authority conferred by paragraph 13 above;
15. Requires any Member State whether acting nationally or through regional organisations or arrangements, when it undertakes an inspection pursuant to paragraph 13 above, to submit promptly an initial written report to the Committee containing, in particular, explanation of the grounds for the inspection, the results of such inspection, and whether or not cooperation was provided, and, if prohibited items for transfer are found, further requires such Member States to submit to the Committee, at a later stage, a subsequent written report containing relevant details on the inspection, seizure, and disposal, and relevant details of the transfer, including a description of the items, their origin and intended destination, if this information is not in the initial report;
16. Deplores the continuing flows of mercenaries into the Libyan Arab Jamahiriya and calls upon all Member States to comply strictly with their obligations under paragraph 9 of resolution 1970 (2011) to prevent the provision of armed mercenary personnel to the Libyan Arab Jamahiriya;
Ban on flights
17. Decides that all States shall deny permission to any aircraft registered in the Libyan Arab Jamahiriya or owned or operated by Libyan nationals or companies to take off from, land in or overfly their territory unless the particular flight has been approved in advance by the Committee, or in the case of an emergency landing;
18. Decides that all States shall deny permission to any aircraft to take off from, land in or overfly their territory, if they have information that provides reasonable grounds to believe that the aircraft contains items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 9 and 10 of resolution 1970 (2011) as modified by this resolution, including the provision of armed mercenary personnel, except in the case of an emergency landing;
Asset freeze
19. Decides that the asset freeze imposed by paragraph 17, 19, 20 and 21 of resolution 1970 (2011) shall apply to all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the Libyan authorities, as designated by the Committee, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, as designated by the Committee, and decides further that all States shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of the Libyan authorities, as designated by the Committee, or individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, as designated by the Committee, and directs the Committee to designate such Libyan authorities, individuals or entities within 30 days of the date of the adoption of this resolution and as appropriate thereafter;
20. Affirms its determination to ensure that assets frozen pursuant to paragraph 17 of resolution 1970 (2011) shall, at a later stage, as soon as possible be made available to and for the benefit of the people of the Libyan Arab Jamahiriya;
21. Decides that all States shall require their nationals, persons subject to their jurisdiction and firms incorporated in their territory or subject to their jurisdiction to exercise vigilance when doing business with entities incorporated in the Libyan Arab Jamahiriya or subject to its jurisdiction, and any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and entities owned or controlled by them, if the States have information that provides reasonable grounds to believe that such business could contribute to violence and use of force against civilians;
Designations
22. Decides that the individuals listed in Annex I shall be subject to the travel restrictions imposed in paragraphs 15 and 16 of resolution 1970 (2011), and decides further that the individuals and entities listed in Annex II shall be subject to the asset freeze imposed in paragraphs 17, 19, 20 and 21 of resolution 1970 (2011);
23. Decides that the measures specified in paragraphs 15, 16, 17, 19, 20 and 21 of resolution 1970 (2011) shall apply also to individuals and entities determined by the Council or the Committee to have violated the provisions of resolution 1970 (2011), particularly paragraphs 9 and 10 thereof, or to have assisted others in doing so;
Panel of experts
24. Requests the Secretary-General to create for an initial period of one year, in consultation with the Committee, a group of up to eight experts (“Panel of Experts”), under the direction of the Committee to carry out the following tasks:
(a) Assist the Committee in carrying out its mandate as specified in paragraph 24 of resolution 1970 (2011) and this resolution;
(b) Gather, examine and analyse information from States, relevant United Nations bodies, regional organisations and other interested parties regarding the implementation of the measures decided in resolution 1970 (2011) and this resolution, in particular incidents of non-compliance;
(c) Make recommendations on actions the Council, or the Committee or State, may consider to improve implementation of the relevant measures;
(d) Provide to the Council an interim report on its work no later than 90 days after the Panel’s appointment, and a final report to the Council no later than 30 days prior to the termination of its mandate with its findings and recommendations;
25. Urges all States, relevant United Nations bodies and other interested parties, to cooperate fully with the Committee and the Panel of Experts, in particular by supplying any information at their disposal on the implementation of the measures decided in resolution 1970 (2011) and this resolution, in particular incidents of non-compliance;
26. Decides that the mandate of the Committee as set out in paragraph 24 of resolution 1970 (2011) shall also apply to the measures decided in this resolution;
27. Decides that all States, including the Libyan Arab Jamahiriya, shall take the necessary measures to ensure that no claim shall lie at the instance of the Libyan authorities, or of any person or body in the Libyan Arab Jamahiriya, or of any person claiming through or for the benefit of any such person or body, in connection with any contract or other transaction where its performance was affected by reason of the measures taken by the Security Council in resolution 1970 (2011), this resolution and related resolutions;
28. Reaffirms its intention to keep the actions of the Libyan authorities under continuous review and underlines its readiness to review at any time the measures imposed by this resolution and resolution 1970 (2011), including by strengthening, suspending or lifting those measures, as appropriate, based on compliance by the Libyan authorities with this resolution and resolution 1970 (2011).
29. Decides to remain actively seized of the matter.
Fonte: http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/17/un-security-council-resolution
Archiviato in Libia, Medio Oriente
Giorgio Lunghini: Ritorno a Keynes?
Vodpod videos no longer available.
Archiviato in Economia
Archivio (Afghanistan: oppio 1998-2008)
Segnaliamo l’impennata iniziata nel 2001.
Rapporto produzione oppio in Afghanistan Istituo-Studi-politica-Internazionale
Archiviato in Afghanistan, Medio Oriente
Caracciolo, i ribelli capitoleranno
Il direttore di Limes non usa mezzi termini, senza aiuti i ribelli libici condannati alla sconfitta.
Vodpod videos no longer available.
Archiviato in Libia, Medio Oriente















